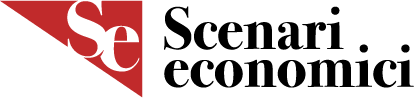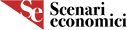AttualitàCultura
Relazioni Internazionali quarta lezione: competizione globale e posizione italiana. Dagli appunti del professor Rinaldi

La competitività del mercato globale.
Il diffuso effetto di forte stimolo alla continua ricerca di una maggiore efficienza aziendale, costituisce un rilevante aspetto positivo dell’accresciuta concorrenza a seguito del processo di liberalizzazione dei mercati. Tuttavia, in un mercato in continua evoluzione mantenere costante una certa posizione competitiva non è sempre semplice. Da qui l’esigenza di elevate capacità da parte dei manager di riuscire a destreggiarsi nel far fronte ai mutamenti, adattandosi rapidamente alle nuove situazioni senza rischiare di compromettere la competitività dell’azienda e cercando anzi di rafforzarla, sfruttando il più possibile le nuove opportunità creatisi con i cambiamenti ed evitando e/o limitandone, per quanto possibile le insidie e i rischi.
Le nuove idee e le conseguenti innovazioni, per essere veramente significative e utili ai fini della competitività dell’impresa, debbono poi “funzionare” in pratica e concretizzarsi in miglioramenti nei prodotti e nei servizi, ovvero nelle tecniche di produzione e nelle strutture organizzative e commerciali.
È compito dei manager gestire il cambiamento creando un clima favorevole all’interno dell’azienda motivando e coinvolgendo tutti i dipendenti e collaboratori.
Per le imprese esportatici dei Paesi avanzati la possibilità di riuscire ad essere competitive sul mercato globale sembra dunque dipendere molto dalla conoscenza accumulata con l’esperienza nell’attività di ricerca e dalla disponibilità di risorse umane altamente qualificate.
La posizione competitiva dell’Italia nel mercato globale.
Il nostro paese, nel confronto con i principali Paesi europei industrializzati, appare in ritardo in riferimento sia alla quota di spesa destinata alla ricerca, sia al livello di istruzione.
Per quanto riguarda il livello di istruzione, la percentuale di laureati nel nostro paese nella fascia di età compresa tra 25 e 64 anni è pari al 14%. La media dei paesi OCSE è del 28%. La media dei paesi dell’Unione Europa a 19 è del 27%. In Corea del Sud è del 37%, negli Usa del 41% in Giappone del 43%.
Tutti i grandi paesi europei hanno una media più alta.
V’è tuttavia da sottolineare che l’Italia ha un serio problema di “brain drain“, cioè di una perdita netta di laureati, la cosiddetta “fuga dei cervelli”.
Gli investimenti nella ricerca invece sono dell’ 1,25% in percentuale di Pil, eppure come è noto, le nuove tecnologie informatiche possono migliorare considerevolmente il modo di operare (e quindi l’efficienza) delle imprese che le adottano.
Nell’attuale contesto competitivo e in presenza di significative differenze (in termini di intensità fattoriale) fra le diverse fasi della produzione, è ragionevole pensare che i Paesi industrializzati, tenuto conto dei diversi vantaggi comparati, abbiano convenienza e quindi tendano a specializzarsi nelle fasi intermedie o finali di alto profilo (trattasi di fasi di lavorazione piuttosto complesse richiedenti elevata conoscenza tecniche lavoro altamente qualificato), lasciando invece ai Paesi meno avanzati le fasi di lavorazione intermedie e finali di basso profilo (come quelle di assemblaggio).
Molte imprese italiane operanti nei vari comparti del Made in Italy, hanno decentrato e continuano a delocalizzare alcune fasi di lavorazione ad alta intensità di lavoro o addirittura l’intera attività produttiva nei Paesi a bassi salari.
In uno scenario competitivo sempre più caratterizzato dall’incalzante concorrenza dei nuovi Paesi produttori, come gli altri Paesi industrializzati anche l’Italia ha visto diminuire la sua quota di mercato sul commercio mondiale passata dal 3,4% nel 2008 al 2,7% nel 2012.
L’impressione è che l’Italia si trovi in una posizione particolarmente svantaggiata, continuando a distinguersi per i seguenti aspetti:
– elevata specializzazione nei settori tradizionali e la scarsa presenza nei settori ad alto contenuto tecnologico. Al di là dei settori di appartenenza, ciò che veramente fa la differenza possono essere solo i settori di nicchia, di alta qualità che esportano e non si rivolgono solo al mercato interno;
– quanto poi all’aspetto sicuramente negativo è costituito dalla scarsa incidenza del settore high tech, associabile alla scarsa incidenza dell’attività di ricerca, nella bassa propensione a investire in R&S, sia da parte del settore pubblico sia quello privato;
– non potendo puntare su segmenti specifici di mercato (es. l’alta tecnologia) che diano la possibilità di competere a livello internazionale, il modello italiano deficia del fatto di essere costituito prevalentemente di piccole e medie imprese, per cui non riesce ad aumentare le esportazioni dato la rilevanza che vuole che esse crescano all’aumentare della dimensione, espressa in termini di addetti.
Alle suddette osservazioni si aggiungono il forte divario a livello territoriale fra le regioni del nord e quelle del sud, con una forte differenziazione nei sistemi di produzione anche all’interno delle stesse regioni, ma soprattutto le significative carenze nella disponibilità di importanti infrastrutture (telecomunicazioni, energia elettrica, rete autostradale e quella ferroviaria), in grado di incidere pesantemente sui livelli di produttività dell’intero sistema economico e quindi sulla crescita.
Dai dati OCSE si evince che al minor grado di terziarizzazione si accompagna un divario negativo nella crescita della produttività: per quelle economie dove maggiore è stata la spesa in tecnologie informatiche e nel settore dei servizi (come Stati Uniti, Francia, Germania), maggiori sono stati i cambiamenti positivi nel processo produttivo che hanno reso possibile un aumento significativo della produttività. In Italia, invece, la minore propensione ad innovare delle imprese e la minore terziarizzazione hanno comportato una crescita di produttività pressoché nulla.
Negli anni precedenti l’attuale crisi, i settori specializzati nel Made in Italy hanno generato un notevole saldo commerciale che ha così contribuito a pagare il pesante deficit delle materia prime, nonché il deficit aggregato degli altri settori manifatturieri (mezzi di trasporto, informatica, elettronica, chimica).
Fatto è che le nuove tecnologie, se applicate senza le opportune modifiche organizzative a livello aziendale e senza il supporto di una forza lavoro qualificata in grado di saperle gestire nel modo più efficiente, possono avere un impatto irrilevante sulla produttività e quindi sulla competitività di un impresa.
È proprio grazie alle nuove tecnologie, nei Paesi industrializzati le imprese che sempre più delocalizzano le loro fasi di produzione nei Paesi a bassi salari, tendono comunque a mantenere il loro core business nel Paese di origine dove fra le altre attività ritenute strategiche continuano a progettare e a innovare i loro prodotti.
Nei Paesi industrializzati quindi, la tenenza è verso una crescente richiesta di lavoro qualificato (rispetto a quello non qualificato).
Globalizzazione e cambiamenti tecnologici sembrano dunque in sinergia aver causato e continuano a causare una maggiore domanda di lavoro qualificato, con rilevanti effetti sull’ampliamento dei differenziali salariali fra i lavoratori qualificati e non (lo skill premium), che ha infatti mostrato aumenti significativi negli ultimi decenni.
L’utilizzo di tecnologie avanzate che fanno largo uso di lavoro qualificato, si può considerare come la risposta strategica, da parte dei Paesi avanzati, per difendersi dalla concorrenza dei nuovi Paesi produttori a bassi salari.
Contro la concorrenza dei Paesi emergenti, le strategie difensive delle imprese distrettuali (e più in generale delle imprese esportatrici italiane) appaiono basate essenzialmente su:
– la qualità delle varietà prodotte e della mano d’opera utilizzata;
– l’ampliamento della gamma delle merci offerte e nell’ottimizzazione delle linee di produzione volte al miglioramento della qualità dei prodotti;
– la specializzazione nelle fasi più rilevanti del processo produttivo, progettazione e design, e il progressivo decentramento all’estero delle fasi più standardizzate.
La qualità del capitale umano è un fattore strategico perché da esso dipendono importantissimi elementi di competitività aziendale, quali le innovazioni tecniche incorporate nel prodotto, l’appeal della marca, la presentazione creativa o il contenuto artistico delle varietà utilizzate.
È opportuno più che mai puntare molto sulla formazione, la disponibilità di lavoratori con elevati livelli di istruzione consente infatti alle imprese non solo di poter sfruttare in pieno tutte le possibilità offerte dal progresso tecnico, ma anche di potersi adattare con maggiore facilità alle nuove e mutevoli condizioni di mercato (date le maggiori capacità e flessibilità decisionali e operative tendenzialmente riscontrabili nei soggetti più istruiti).
Un problema molto serio deriva dal fatto che i Paesi emergenti a bassi salari possono permettersi di attuare un sorta di concorrenza sleale attraverso il cosiddetto dumping sociale, cioè praticare bassi prezzi all’estero per i loro prodotti proprio perché in essi il costo del lavoro si mantiene molto basso per effetto degli scarsi livelli di protezione sociale dei lavoratori, cosicché l’esistenza di bassi standard lavorativi in termini di sicurezza e tutela del lavoro, consente loro un vantaggio competitivo “sleale”, basato essenzialmente sullo sfruttamento dei lavoratori.
Il vantaggio competitivo di un Paese in un determinato settore tuttavia non dipende solo dal divario in termini di salari, ma anche dal divario in termini di produttività nei confronti di un altro Paese: in quelli industrializzati non solo lo stato sociale ma anche la produttività del lavoro, tende a essere mediamente più elevata in tutti i settori rispetto a quanto rilevabile in un Paese meno avanzato; mente v’è da dire che nei paesi emergenti, gli inferiori livelli salariali riflettono anche una minore produttività media del lavoro a livello aggregato, in riferimento cioè a tutti i settori.
Alcuni economisti hanno evidenziato l’importanza della problematica connessa ai discussi effetti perversi della globalizzazione sul mercato del lavoro.
Si è parlato del l’opportunità di affrontare la questione all’interno della WTO (World Trade Organization) al fine di giungere alla definizione di appropriati standard lavorativi minimi a livello internazionale e alla previsione di sanzioni commerciali, come l’applicazione di restrizioni quantitative alle importazioni provenienti da Paesi caratterizzati da condizioni del mercato al di sotto di detto standard lavorativi minimi.
A seguito di queste problematiche nei Paesi industrializzati è stata così sempre più avvertita l’esigenza di una maggiore protezione o ricorso a qualche forma di Protezionismo. Si è pertanto riaperto il dibattito relativo alla maggiore o minore opportunità per un Paese di ricorrere a politiche commerciali basate sul libero scambio oppure sul protezionismo.