Analisi e studi
Perché i salari italiani restano strutturalmente più bassi della media europea
Non è colpa della “sfortuna”. Dati alla mano, ecco perché l’architettura dell’Eurozona e la mancata produttività hanno trasformato il lavoro nell’unica variabile di aggiustamento.

Il persistente divario tra i salari italiani e quelli medi dell’area euro non può essere spiegato con fattori ciclici, ritardi temporanei di aggiustamento o presunte rigidità del mercato del lavoro. Esso rappresenta, piuttosto, l’esito coerente di una traiettoria economica che si è consolidata negli ultimi venticinque anni, trasformando l’Italia in un’anomalia tra le principali economie avanzate. Secondo l’OCSE, tra il 1995 e il 2022 i salari reali medi italiani sono rimasti sostanzialmente stagnanti, mentre nello stesso periodo sono cresciuti di oltre il 30% in Germania e di circa il 25% in Francia.
Alla base di questa divergenza vi è innanzitutto la dinamica della produttività. I dati Eurostat sulla produttività reale per ora lavorata mostrano che, dal 1999 fino alla vigilia della pandemia, l’incremento cumulato italiano è stato inferiore al 10%, contro aumenti compresi tra il 15 e il 25% nelle principali economie dell’area euro. Questa stagnazione non riflette una minore intensità del lavoro, ma una debolezza strutturale della produttività totale dei fattori, legata a insufficiente diffusione tecnologica, ridotta dimensione media delle imprese e carenze nell’accumulazione di capitale organizzativo.
In un’economia caratterizzata da una crescita debole della produttività, la competizione si sposta inevitabilmente sul terreno dei costi. Ed è qui che emerge il nodo centrale: l’architettura dell’unione monetaria. Con l’ingresso nell’euro, l’Italia ha rinunciato allo strumento del cambio nominale come meccanismo di riequilibrio competitivo. In un sistema di cambi irrevocabilmente fissi, i differenziali di inflazione e di produttività non possono più essere compensati attraverso aggiustamenti valutari. L’aggiustamento viene così trasferito sui costi interni, in primo luogo sul costo del lavoro.
La cosiddetta “svalutazione interna” non è stata una scelta discrezionale di politica economica, ma una conseguenza strutturale di un’unione monetaria priva di adeguati meccanismi di compensazione. In assenza di un bilancio federale, di trasferimenti automatici e di una capacità fiscale comune, l’onere dell’aggiustamento agli shock asimmetrici è ricaduto sistematicamente sui salari, trasformando il lavoro nella principale variabile di aggiustamento macroeconomico. Un assetto che impone la disciplina attraverso i redditi, anziché assorbirla tramite strumenti fiscali e monetari comuni, genera inevitabilmente pressioni deflazionistiche interne e comprime la domanda. Non è un caso che già Paolo Baffi mettesse in guardia dai rischi insiti in regimi di vincoli monetari rigidi, sottolineando come, in assenza di strumenti di riequilibrio, la pressione finisca per scaricarsi sull’economia interna e sui redditi da lavoro: un’intuizione che anticipa molte delle critiche oggi rivolte all’euro.
Le riforme del mercato del lavoro introdotte a partire dagli anni Duemila si inseriscono pienamente in questo quadro. L’aumento della flessibilità contrattuale e la proliferazione delle forme di lavoro atipico non hanno prodotto un’accelerazione della produttività, ma hanno contribuito a ridurre il potere contrattuale medio, facilitando la compressione salariale. Non a caso, nello stesso periodo la quota dei redditi da lavoro sul PIL si è ridotta in Italia di circa cinque punti percentuali, più che nella media dell’area euro.
Il confronto con le economie dotate di piena sovranità monetaria è illuminante. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, gli shock macroeconomici sono stati assorbiti prevalentemente attraverso politiche fiscali e monetarie espansive, consentendo un sostegno più diretto alla domanda e ai salari. Nell’area euro, soprattutto nel decennio successivo alla crisi del debito sovrano, l’aggiustamento è avvenuto quasi esclusivamente tramite la compressione dei costi interni, in un contesto di politiche macroeconomiche restrittive.
L’elevata copertura della contrattazione collettiva in Italia, superiore all’80 per cento dei lavoratori, conferma che il problema non risiede nell’assenza di tutele formali, ma nel vincolo macroeconomico in cui la contrattazione stessa è costretta a operare. In un contesto di domanda debole e di cambio rigido, anche la dinamica salariale diventa endogenamente recessiva. A ciò si aggiunge un cuneo fiscale tra i più elevati dell’OCSE, che riduce il salario netto e amplifica l’effetto depressivo sulla domanda interna.
I bassi salari italiani non sono dunque una fatalità né il risultato di inefficienze politiche o dei sindacati, ma l’esito coerente di un modello di competitività fondato sulla compressione del costo del lavoro, reso necessario da un’architettura monetaria che ha eliminato il cambio senza introdurre strumenti alternativi di riequilibrio. In questo assetto, il lavoro non è una variabile residuale: è la principale leva di aggiustamento.
*ex membro Commissione ECON del Parlamento europeo
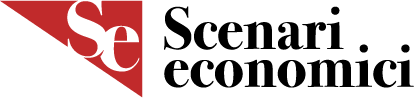
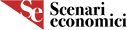






You must be logged in to post a comment Login