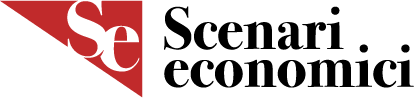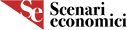Economia
“Made in Italy” (o no?)
Le cifre ufficiali per il 2014 parlano di un surplus commerciale italiano (differenza tra esportazioni e importazioni) che a fine anno sarà pari a circa €50 miliardi, ed è sicuramente un bene per la nostra disastrata economia, ma è tutt’oro quello che luccica? È davvero tutto vero “made in Italy” ciò che troviamo con questo nome sulle etichette dei prodotti che acquistiamo?
Un paio di settimane fa la trasmissione “La gabbia” si è occupata del “made in Italy” alimentare con riferimento particolare ad une delle eccellenze italiane: i salumi. In studio era presente la vice presidente di CONFINDUSTRIA con delega alla valorizzazione del “made in Italy” nel mondo, la signora Ferrarini, titolare del noto marchio emiliano. Veniva contestato ad ella, come titolare d’azienda e rappresentante della categoria, la mancanza della provenienza delle carni nelle etichette di prosciutti e affini, cosa che non è stata resa obbligatoria dalla legge sulla trasparenza del prodotto al consumatore ma che nessuno ha mai vietato di fare a chi l’avesse voluto.
Del resto i numeri parlano chiaro: solo circa il 30% delle carni impiegate nella filiera produttiva proviene dagli allevamenti italiani mentre il resto arriva dagli altri Paesi della U€, soprattutto da Francia, Olanda e Germania. Ovvero, solo TRE prodotti su DIECI che finiscono sulle tavole sono realmente italiani. E questo è un fatto. Adesso analizziamo un altro aspetto, il più inquietante: realmente le altre carni da dove provengono? Sembra che una grossa fetta delle carni importate (che poi viene finito di lavorare in Italy) provenga realmente da Romania, Bulgaria, Ungheria e anche Turchia che grazie ad accordi bilaterale con Olanda, Francia e Germania (ma non solo) aggirano i blandi vincoli imposti dalla U€. basta che un animale arrivi in un paese comunitario e, come per incanto, dopo poche settimane prende cittadinanza dello stesso e diventa pronto per la successiva riesportazione. Altro che Jus solis! Nel servizio si parla anche della chiusura del 60% delle porcilaie italiane che non potevano assolutamente competere con aziende estere e non comunitarie che oltre ad avere costi inferiori che arrivano anche al -70% non hanno neppure da ottemperare ad obblighi sanitari stringenti. Della serie cornuti e mazziati.
Eppure TUTTI i salumi (ma non solo) che troviamo nei supermercati riportano la dicitura che ci tranquillizza e rende felici: “made in Italy”. Quando le nostre aziende di trasformazione si decideranno ad inserire in etichetta la provenienza delle carni e di tutta la filiera in generale sarà sempre troppo tardi.
Avete mai comprato un cappellino, una t-shirt o altro capo a marchio “Ferrari”? chi l’ha fatto sa benissimo che un cappellino “originale” (e con tanto di altri sponsor annessi) costa intorno ai 60 €uro. Leggete l’etichetta e (cercando di non bestemmiare) rendetevi conto che vi è un bel “made in altraparte”. Eppure quel prodotto è considerato, quanto viene esportato, a tutti gli effetti “made in Italy”.
In quanti sanno che per fregiarsi del marchio “made in Italy” basta che il 30% del prodotto sia confezionato in Italia? Ad esempio, basta che ad un paio di scarpe fabbricate in Laos, India, Vietnam ecc si aggiungano lacci, marchietto, lustrini vari e scatola (tutti fabbricati anch’essi da “altraparte”) per ottemperare ai requisiti richiesti: pure questo diventa per incanto “made in Italy”.
I gruppi Benetton, Oviesse, Terranova ecc producono tutti da “altraparte” (ricordate la tragedia in Bangladesh dove morirono 1500 lavoratori sottopagati?): quanto queste multinazionali esportano quello diventa “made in Italy”.
Anche nell’abbigliamento di lusso, anzi, soprattutto in quel settore, è prassi più che consolidata. Oramai è noto a quasi tutti che una borsa di Prada rivenduta anche a 1000 €uro ne costi realmente poche decine.
C’è un altro aspetto interessante segnalatomi da un lettore operante nel settore. Vi siete mai chiesti il perché ogni anno che passa le svendite partono sempre prima? Esse arrivano in pochi giorni anche al -70%, cifra a cui la stragrande maggioranza dei piccoli commercianti non può arrivare poichè accuserebbero perdite secche in conto capitale così forti da portarli alla chiusura o al fallimento in poche stagioni. Le multinazionali dell’abbigliamento che producono da “altraparte” a costi RIDICOLI continuerebbero ad avere lauti guadagni anche con sconti superiori al -90% (un paio di jeans costa poco più di 80 centesimi di dollaro e un paio di scarpe non più di 2 $). Essi, con le svendite folli, continuano a guadagnare come produttori e nello stesso tempo, le loro holding commerciali, scaricano come perdite operative le percentuali mancanti dal prezzo di acquisto (ad es. se la holding “taldeitali” prende dalla casa madre dei jeans a 30 €uro per rivenderli a 50 e poi in fase di saldi li rivende a 15, al fisco italiano scaricherà come perdita netta il 50%). La holding commerciale avrà un forte sconto tributario, andando spesso anche in perdita operativa, mentre la casa madre vedrà aumentare le vendite e di conseguenza i profitti.
Quanto all’estero comprano una “Panda” costruita in Polonia o in Serbia quello è “made in Italy” e va a formare, insieme a tutti quei prodotti sin qui elencati, il nostro export, che è italiano (anche come ricadute occupazionali, tasse, dividenti ecc) forse nella misura del 30%.
Sono così lontani i tempi dove gli imprenditori italiani acquistavano materia prima all’estero che poi veniva trasformavata in prodotto finito interamente sul suolo nazionale, dando vita al vero made in Italy 101%. Sono così lontani i tempi quando IRI vendeva sottocosto l’acciaio alle aziende italiane pur di mantenere alto il livello occupazionale.
Questo ragionamento deve anche far capire che tipo di impatto potrà avere un €uro “debole” in termini di ricadute sull’intera economia italiana: sarà quasi nullo poiché, laddove le vendite extra-U€ dovessero incrementare (e con la deflazione globale che è in atto nutro più di qualche dubbio che ciò possa verificarsi) andrebbero a portare il 70% dei benefici occupazionali da “altraparte”, aumentando solo il numero di schiavi in giro per i Paesi poveri che producono per qualche centesimo di dollaro il cappellino della Ferrari, le tod’s, i vestiti di Armani ecc.
Adesso, ditemi, secondo voi, i grandi industriali italiani potrebbero mai desiderare un ritorno alla £ira? GIAMMAI! Dalla politica hanno avuto tutto il desiderabile: la possibilità di esportare capitali, di impiantare fabbriche dove più gli aggrada (vendendo dappertutto i prodotti ivi costruiti), una moneta “forte” che gli permette di avere i massimi vantaggi e anche gli ammortizzatori sociali dove parcheggiare i lavoratori in esubero, accollandone i costi alla comunità. Adesso hanno ottenuto l’abolizione dell’art. 18 e a breve avranno anche in Italia frotte di disperati disposti a lavorare per pane e acqua. Un’ultima cosa chiedono: la riduzione del cuneo fiscale che, ovviamente, andrà finanziato con tagli lineari alla spesa pubblica e svendite di Stato.
Uno Stato privo di qualsiasi autonomia ed autodeterminazione, che non riesce più ad imporre la sua autorità a salvaguardia del Popolo, finisce ricattato dalla finanza e dall’industria multinazionale.
L’Italia è morta ogni qualvolta i suoi politici hanno firmato quei trattati capestro, a partire dall’adesione allo SME nel lontano 1978.
Roberto Nardella.