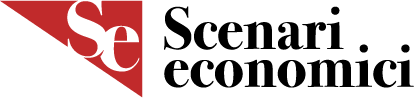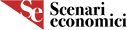Attualità
La PNL, l’ancoraggio e come ti “educo” ad amare la UE

Uno strumento interessantissimo della programmazione neurolinguistica va sotto il nome di “ancoraggio”. Consiste nell’associare (“ancorandola”, appunto, come si farebbe con una barca al molo) una certa sensazione – diciamo pure uno “stato emotivo” – a un suono, a un’immagine o a un gesto qualsiasi. Attraverso questo piccolo accorgimento, chiunque è in grado di rievocare all’istante l’emozione di cui ha bisogno nel preciso momento in cui gli serve. E potrà riuscirci semplicemente richiamando alla propria attenzione il suono, l’immagine, il gesto a cui quell’emozione era stata in precedenza “agganciata”.
È più facile a farsi che a spiegarsi.
Pensate a un oratore il quale voglia sentirsi sicuro di se stesso e pieno di energia quando comincia a parlare in pubblico, magari davanti a una platea folta e qualificata. Lo aiuterà, nei giorni precedenti la prova, fare qualche piccolo esercizio di concentrazione. Egli cercherà di recuperare – e di rivivere nei minimi dettagli – esperienze del suo passato dove si è sentito convinto dei propri mezzi, risoluto, trascinante. Ma non deve trattarsi per forza di un ricordo vero. Potrà essere anche un’esperienza immaginata vividamente nella propria mente e rivissuta, attraverso opportuni “rewind” virtuali, più e più volte. Gradualmente, costui comincerà ad avvertire dentro di sé delle sensazioni corrispondenti al “film” che sta girando nel suo schermo interiore. Si sentirà inevitabilmente a suo agio, tranquillo, padrone della situazione.
Il nostro uomo dovrà, a questo punto, associare quella che, in gergo, viene definita un’ancora al picco più alto della piacevole sensazione percepita durante l’esperimento: un gesto qualsiasi (per esempio, una frizione del pollice o lo sfregamento delle mani) oppure una parola chiave (per esempio, “vittoria”) o un colore (per esempio, il verde) oppure tutte queste cose messe assieme. Dopo che avrà ripetuto per un po’ di volte questa procedura, cosa accadrà? Semplice: gli basterà frizionare il pollice o sfregarsi le mani o sillabare sottovoce la password prescelta o visualizzare il colore stabilito per riavvertire quel quid di forza, energia, sicurezza di cui ha bisogno. Ed esattamente nell’istante in cui le circostanze lo richiedono.
Molti dei cosiddetti “riti scaramantici” adottati dai campioni dello sport, soprattutto in epoche recenti, non hanno nulla a che vedere con la scaramanzia volgarmente intesa. Il fatto di allacciarsi le scarpe in un certo modo o di entrare in campo prima con il piede destro che col sinistro, o viceversa, e mille altri accorgimenti simili costituiscono degli “ancoraggi”. Lo sportivo esegue determinate azioni abitudinarie, ritualmente ripetute, perché ha associato in precedenza a quelle azioni una sensazione di benessere o di euforia o un misto di entrambe o qualsiasi altra emozione positiva ed energizzante possa venirvi in mente.
Ciò può accadere grazie al lavoro di un coach motivazionale (oramai tutti gli atleti di alto livello e tutte le squadre professionistiche di grido ne hanno uno). Ma può anche essere il frutto di una estemporanea decisione, solo in apparenza scaramantica.
Classico il caso delle squadre che preferiscono disputare certe finali con le magliette di riserva anziché con quelle ufficiali perché avevano vestito quella stessa casacca nell’ultima competizione vinta. Anche quando ciò non succede per una applicazione consapevole della tecnica di cui stiamo parlando, la ragione di fondo è sempre la stessa. Indossare un abito o accompagnarsi a un amuleto “vincente” suscita gli stati d’animo corrispondenti e desiderati. Quelli che i francesi chiamano état d’esprit e gli inglesi mood, per capirci.
Questo, in estrema sintesi, è l’ancoraggio.
In fondo, si tratta dell’applicazione pratica del principio del cane di Pavlov. Ivan Pavlov era un fisiologo ed etologo russo, studioso del comportamento degli animali, vissuto tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento e passato alla storia – anche della psicologia – come il teorico del “riflesso condizionato”. Egli scoprì come un cane, cui si somministri in diverse occasioni il cibo dopo aver fatto suonare una campanella, finirà per salivare – manifestando così il suo appetito – al semplice suono della campana, benché non accompagnata dalla ciotola. La salivazione si trasforma in un riflesso condizionato. Insomma, dopo un certo numero di occasioni in cui la pappa arriva annunciata dallo scampanellio, a Fido verrà l’acquolina in bocca a prescindere dai bocconcini.
Ma non serve scomodare Pavlov per capirlo. Basta pensare a quel famoso tormentone estivo in voga ai tempi del vostro primo amore. Ancor oggi, nel riportarlo alla memoria, vi torneranno in mente le gioie e le ansie di quella cotta adolescenziale. Marcel Proust, su questa solare verità, ha costruito il suo capolavoro immortale: Alla ricerca del tempo perduto.
L’opera del grande scrittore, infatti, comincia proprio da una irresistibile emozione di felicità e benessere suscitata dal… morso di un biscotto. Ecco cosa accade esattamente al protagonista:
«Una sera d’inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere, contro la mia abitudine, un po’ di tè. Dapprima rifiutai, poi, non so perché, mutai parere. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati madeleine, che sembrano lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, portai macchinalmente alle labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato inzuppare un pezzetto di madeleine. Ma appena la sorsata mescolata alle briciole del pasticcino toccò il mio palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario che si svolgeva in me. Un delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, senza nozione di causa. E subito, m’aveva reso indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della vita… non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale. Da dove m’era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo che era connessa col gusto del tè e della madeleine».
Ma ora, dai cieli della letteratura universale, torniamo al nostro discorso terra terra. Nel caso dell’Unione europea, come funziona la faccenda? In diversi modi.
Intanto, il più pacchiano: quello di associare la bandiera blu oro- stellata al vessillo tricolore. Pensate a quanti edifici pubblici italiani (tutti, purtroppo) sono agghindati con entrambi gli stendardi. Questa è una forma esemplare di ancoraggio. La bandiera dell’Unione europea viene costantemente “ancorata” a quella dell’Italia. E quella dell’Italia, com’è noto, è ancora in grado di emozionare anche il più disincantato e meno romantico dei nostri concittadini. Si pensi al moto d’orgoglio con cui molti connazionali vibrano di fierezza – e avvertono l’istinto di portare la mano sul cuore e di sillabare il ritornello dell’inno di Mameli – quando parte la fanfara all’inizio delle partite di calcio della nostra nazionale.
Ma aldilà del calcio, non v’è dubbio che la stragrande maggioranza degli italiani è felice di esser tale, di sentirsi parte viva e attiva della propria patria. E prova forti e belle emozioni ogni qualvolta vede sventolare il tricolore. Dopotutto, anche questo è frutto di un ancoraggio. Centocinquant’anni di unità nazionale hanno prodotto il loro risultato.
Ma torniamo all’altra bandiera, quella neutra dell’Unione europea che probabilmente, oggi come oggi, riesce a far emozionare solo Claude Junker e Mario Monti.
Cosa accade nell’istante in cui essa viene ripetutamente abbinata a quella verde, bianca e rossa? Sulle prime nulla, è chiaro. Ma poi? Nel lungo periodo? Quando l’avremo vista migliaia e migliaia di volte? Esatto, avete capito. La bandiera blu oro-stellata ci farà emozionare proprio come il campanello di Pavlov faceva salivare il suo cane affamato.
Una chicca, in proposito, è il consiglio contenuto nel libro L’arte della guerra di Sun Tzu: «Sostituisci le bandiere e gli stendardi nemici coi tuoi». È esattamente quello che hanno cominciato a fare. E state ben sicuri che, un bel giorno, quando sarà ultimata l’operazione di sostituzione dell’Italia con gli Stati Uniti d’Europa, anzi di liquefazione dell’Italia negli USE, anche le bandiere tricolori finiranno in un cassetto: proprio come è accaduto alla tradizionale bandiera del Regno d’Italia con il famoso blasone campeggiante all’interno della banda bianca centrale.
Tuttavia, ci sono anche altre forme di ancoraggio, meno evidenti, cui dobbiamo prestare attenzione. Una è quella delle parole. Si prende una parola a cui è tradizionalmente assegnata una valenza positiva e si crea un neologismo di valenza opposta. Oppure si impone, nell’uso corrente delle chiacchiere da bar e dei cinguettii via social, un nuovo sostantivo derivato da quello originario (positivo) e gli si associa una carica spregiativa. Esempio insuperabile: la parola “sovranità”.
La sovranità è così importante da essere stata inserita persino nella nostra Costituzione, e non in fondo al testo ma addirittura nel suo incipit, all’articolo 1: «La sovranità appartiene al popolo», eccetera eccetera. Essa è importante proprio perché è coniugata con il sostantivo “popolo”. Tradizionalmente, la sovranità è sempre stata una faccenda di re, imperatori, élite: sovrani, appunto. Con l’avvento delle democrazie moderne, essa è tornata in mano al popolo proprio come alle sue origini, quando il buon Clistene, nell’agorà di Atene, propose la sua celebre riforma negli ultimi anni del VI secolo a.C. In effetti, lo sappiamo tutti, il termine “democrazia” è un vocabolo di origine greca antica che significa, appunto, “governo del popolo”.
Ebbene, oggi, nei tempi grami in cui viviamo, la sovranità è diventata qualcosa di perverso, di negativo. Il popolo deve imparare a disfarsene. Quante volte avete sentito il refrain: “L’Europa unita necessita di cessioni di sovranità dei singoli Stati”? Come dimenticare la famosa esortazione di Monti, in proposito: «Non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi, e di gravi crisi, per fare passi avanti. I passi avanti dell’Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto, visibile, conclamata».
A volte ve la raccontano anche così: “Bisogna superare gli nazionali”. Sappiate che quella sovranità è la vostra e quello che loro chiamano “egoismo” voi lo chiamereste “essere padroni a casa propria, autonomi e indipendenti”.
Purtroppo, se la pensate ancora così, siete nati o vivete nel secolo sbagliato. Questa è l’era della fine della democrazia, dell’avvento delle tecnocrazie elitarie, della rottamazioni degli Stati nazionali. Peccato che solo nell’alveo degli Stati nazionali una qualche forma di democrazia “sensata” è ancora possibile: anche per ragioni legate alla loro limitata estensione e alla compresenza, nel territorio, di un popolo generalmente legato da tradizioni linguistiche ed etniche comuni.
E allora? E allora, siccome la sovranità la vogliono mandare al macero, si sono diffuse alla velocità della luce due parole di quasi nuovo conio: “sovranista” e “sovranismo”. Con il preciso intento, badate bene, di associare alle stesse il significato deteriore di qualcosa da cui guardarsi per la sua intrinseca pericolosità.
Il sovranista, alla pari del populista, è chi non ci sta: il riottoso, il renitente, il resistente, l’arci-nemico dei nuovi padroni. I nuovi padroni – che ovviamente possiedono, gestiscono o occupano la quasi totalità del sistema mediatico generalista – lo hanno messo nel mirino. E hanno premuto il grilletto di un “ancoraggio” sonoro ben preciso: la parola sovranista viene sempre e sistematicamente associata a valori, personaggi, pensieri negativi. Persino Papa Bergoglio non ha mancato di dare il suo contributo alla causa anti-sovranista:
«Il sovranismo è un’esagerazione che finisce male sempre: porta alle guerre. Lo stesso discorso vale anche per i populismi. […] Il popolo è sovrano (ha un modo di pensare, di esprimersi e di sentire, di valutare), invece i populismi ci portano a sovranismi: quel suffisso, “ismi”, non fa mai bene».
Il che del resto non deve sorprendere. Parliamo del pontefice più amato di sempre dall’establishment. Un papa che piace alla gente che piace, diciamo. E alla gente che piace, come sapete, il popolo e la sovranità non piacciono affatto.
A ogni buon conto, i nuovi maestri ci spiegano che, in molti Paesi, avanza la “ondata sovranista” che spesso è composta da movimenti “di destra”, “populisti”, “qualunquisti” quando non “nazionalisti” (anche “nazione” è un vocabolo odiato dai Mercati e dai tecnocrati) o addirittura “fascisti”.
Anche in questo caso, l’ancoraggio non è immediato (come per la bandiera e come per qualsiasi altro ancoraggio), ma alla fine funziona. Esso, infatti, innesta nella nostra debole mente, sopraffatta da troppi stimoli, un concetto insidioso: il sovranista è sovversivo, cattivo e pericoloso proprio come la sovranità stessa, un arnese obsoleto di cui non c’è più bisogno.
Però, “sovranità” è una parola ancora troppo densa di significati positivi (è inscritta nell’articolo 1 della nostra Costituzione!). Così, viene sostituita sempre più spesso da un vocabolo (“sovranismo”) derivante dalla stessa, ma il cui suffisso è essenzialmente negativo. Non dimentichiamo l’ammonimento del papa sopra riportato: «I populismi ci portano a sovranismi: quel suffisso, “ismi”, non fa mai bene». Ecco, appunto.
Alla fine, la tentazione, per molti, sarà quella di buttare via il bambino (cioè la sovranità nazionale) con l’acqua sporca (cioè il sovranismo).
In una recente ricerca, il Censis si è concentrato sullo stato d’animo del Belpaese. E sapete cos’ha scoperto? Che gli italiani sarebbero preda di
«una reazione pre-politica con profonde radici sociali, che alimentano una sorta di sovranismo psichico, prima ancora che politico che talvolta assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio»56.
Insomma, in primis non saremmo più in grado di fare scelte politiche sensate, solo pre-politiche. E poi, non solo siamo sovranisti in politica, il che – par di capire – per il Censis è come bestemmiare in chiesa. Siamo persino “sovranisti psichici”.
In pratica, la parola “sovranità” che già di per sé, poverina, godeva di una pessima reputazione (pur avendo trovato inopinato asilo nell’articolo uno – dicesi uno – della nostra Costituzione) è stata derubricata al rango di patologia mentale. Per questo, se non stiamo attenti, ogniqualvolta sentiremo squillare la parola sovranista, rischieremo di “salivare” obbedienza al futuro che avanza. E ogni volta, un po’ di più, ci allontaneremo da quella sovranità popolare per la quale molti nostri avi sono morti combattendo.
Francesco Carraro
www.francescocarraro.com

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.