EconomiaPolitica
Quello che non è stato detto sul “Rapporto Draghi”
Esaminando il Rapporto Draghi 2025 e il suo discorso al Meeting di Rimini, emerge che le sue proposte per l’Unione Europea si scontrano con i Trattati di Maastricht e Lisbona. Approfondiamo perché il debito comune, la difesa congiunta e una politica industriale centralizzata sono difficili da attuare senza una radicale revisione.

Prendo spunto dall’intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione per sviluppare alcune considerazioni di natura strettamente tecnica.
Non intendo soffermarmi, in questa sede, sulle interessanti evoluzioni dell’approccio ideologico all’integrazione europea emerse nel discorso dell’ex Presidente del Consiglio, già intuibili sin dai tempi della sua tesi di laurea.
Preferisco concentrarmi sull’analisi delle proposte contenute nel Rapporto pubblicato nel marzo di quest’anno, alla luce anche delle riflessioni offerte a Rimini.
Dall’analisi delle misure delineate nel Rapporto Draghi 2025 per il rilancio dell’Unione Europea, emerge subito – a mio avviso – che molte delle soluzioni prospettate difficilmente possono essere realizzate, in quanto risultano incompatibili con specifici articoli dei Trattati su cui si fonda l’Unione: Maastricht (TUE) e Lisbona (TFUE).
Vediamo più nel dettaglio i punti principali.
1. Debito comune permanente ed emissione di obbligazioni
Riferimenti ai Trattati:
- L’UE può emettere titoli di debito, ma solo in circostanze eccezionali, come avvenuto con il NextGenerationEU, fondato sull’art. 122 TFUE (misure assistenziali) o sull’art. 311 TFUE (risorse proprie).
- I Trattati non prevedono un meccanismo permanente di emissione di debito comune: tali strumenti sono concepiti esclusivamente come risposta a emergenze.
- L’introduzione di un debito comune stabile richiederebbe una sostanziale modifica dei Trattati, con approvazione unanime da parte degli Stati membri.
Tensione giuridica: La proposta di un “debito comune permanente” oltrepassa quindi l’attuale cornice giuridica, che ammette soltanto interventi temporanei e legati a contesti straordinari.
2. Finanziamenti di difesa congiunti e obbligazioni sovrane per la difesa
Riferimenti ai Trattati:
- La Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), disciplinata dagli artt. 42-46 TUE, non contempla una difesa comune pienamente integrata, lasciando agli Stati membri la competenza principale.
- L’art. 352 TFUE (clausola di flessibilità) permette azioni solo se necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei Trattati, ma non giustifica strumenti permanenti di questo tipo.
Tensione giuridica: Le obbligazioni comuni per finanziare la difesa richiederebbero un livello di integrazione non previsto dall’attuale assetto giuridico. Sarebbe quindi necessaria una revisione dei Trattati o l’introduzione di una base giuridica ad hoc.
3. Politica industriale e maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato
Riferimenti ai Trattati:
- L’art. 107 TFUE disciplina rigidamente gli aiuti di Stato, ammettendo deroghe solo in casi eccezionali, come progetti di “interesse comune europeo”, da autorizzare comunque dalla Commissione.
- In passato, l’interpretazione di queste norme ha generato forti contrasti tra gli Stati membri, con applicazioni percepite come asimmetriche: più rigorose con alcuni, più tolleranti con altri.
Tensione giuridica: Una politica industriale centralizzata, che richieda deroghe generalizzate alla disciplina sugli aiuti di Stato, entrerebbe in diretto conflitto con uno dei principi fondanti del Mercato Unico.
4. Governance UE più centralizzata e decisioni a maggioranza
Riferimenti ai Trattati:
- In materie sensibili come energia, difesa e fiscalità, i Trattati richiedono l’unanimità (art. 192 par. 2 e art. 113 TFUE; art. 31 TUE).
- L’art. 48 TUE disciplina la revisione dei Trattati, che richiede comunque procedure complesse e l’unanimità degli Stati membri.
Tensione giuridica: La proposta di Draghi di adottare decisioni più rapide e centralizzate si scontra con il vincolo dell’unanimità. Ogni tentativo di superare tale principio è stato finora respinto, per timore che si possano creare alleanze tra alcuni Stati a scapito di altri – rischio ben presente ai Padri Fondatori.
Conclusioni
Le proposte del Rapporto Draghi offrono spunti interessanti per rafforzare la competitività dell’Unione Europea e restituirle il ruolo che spetta a un’area economica avanzata di 450 milioni di abitanti. Tuttavia, restano inattuabili perché in evidente contrasto con i Trattati vigenti.
Qualsiasi revisione profonda che rendesse operative tali misure dovrebbe inoltre essere anche accompagnata da una ridefinizione del mandato della Banca Centrale Europea. Oltre alla stabilità dei prezzi, cioè al controllo dell’inflazione, la BCE dovrebbe includere tra i propri obiettivi la piena occupazione, insieme alla funzione – comune a tutte le principali banche centrali – di prestatore di ultima istanza e di garante del tasso di cambio. Naturalmente, tali funzioni andrebbero esercitate con la piena indipendenza prevista dagli statuti di tutte le Banche Centrali.
Va ricordato che sono trascorsi 33 anni dal Trattato di Maastricht e 39 dal Rapporto Delors, che ne tracciava le linee guida. Nel frattempo il mondo è profondamente cambiato:
- la globalizzazione si è affermata senza regole comuni condivise,
- i nuovi equilibri geopolitici hanno ridisegnato le aree economiche,
- a burocrazia di Bruxelles ha mostrato difficoltà ad adattarsi a queste trasformazioni.
Il risultato è che una delle aree economicamente più forti del mondo non è riuscita ad adeguarsi, ritrovandosi in posizione marginale sia sul piano economico sia su quello geopolitico.
Il Rapporto Draghi coglie la natura dei problemi, ma ignora che le soluzioni proposte non sono compatibili con l’attuale quadro giuridico, neppure con modifiche parziali. Per renderle possibili, sarebbe necessaria una radicale revisione dell’intero impianto normativo e istituzionale dell’Unione: dai Trattati ai regolamenti, fino al mandato della BCE.
Prendere atto che l’errore iniziale è stato quello di affidare alla moneta comune un ruolo di aggregazione politica, senza aver prima raggiunto un’effettiva integrazione economica e istituzionale.
Ma se l’Unione vuole veramente un futuro deve ricordarsi di andare incontro alle esigenze dell’economia reale e dei suoi cittadini considerandoli non sudditi ma i veri “azionisti di maggioranza”
Ai posteri il compito di stabilire chi avesse ragione.
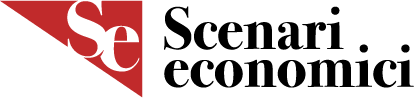
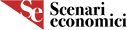





You must be logged in to post a comment Login