Analisi e studiEconomia
Il mito del libero mercato globale e i suoi esiti reali
Il mito del Mercato Globale: Rinaldi svela perché i prezzi non scendono (e chi ci guadagna davvero)

La globalizzazione è stata costruita sull’assunto che l’estensione del libero mercato su scala mondiale avrebbe aumentato l’efficienza allocativa, migliorando la qualità di beni e servizi e riducendone i prezzi attraverso una concorrenza più intensa. Tale impostazione presupponeva mercati contendibili, domanda sufficientemente elastica e un effettivo trasferimento dei guadagni di produttività ai consumatori. I risultati osservabili mostrano che queste condizioni non si sono realizzate.
L’apertura dei mercati ha favorito una crescente concentrazione industriale. Le economie di scala, l’accesso privilegiato ai capitali e il controllo delle catene globali del valore hanno consentito ai grandi gruppi multinazionali di rafforzare il proprio potere di mercato. In numerosi settori l’aumento della produttività non si è tradotto in una riduzione dei prezzi, ma in un incremento dei margini operativi e dei mark-up, segnalando un passaggio da assetti concorrenziali a strutture oligopolistiche.
Le delocalizzazioni, presentate come strumento di efficienza, hanno inciso soprattutto sul lato dei costi, comprimendo salari e occupazione nei paesi avanzati. Tuttavia, in presenza di una domanda finale a bassa elasticità, i risparmi ottenuti non sono stati trasferiti ai consumatori, ma assorbiti sotto forma di extra-profitti. Ne è derivata una redistribuzione del reddito dal lavoro al capitale, con effetti depressivi sulla domanda aggregata e sulla crescita potenziale.
Sul piano macroeconomico, la riduzione dei costi medi è stata perseguita sacrificando la resilienza dei sistemi produttivi. Catene del valore eccessivamente ottimizzate hanno ridotto la ridondanza e aumentato la vulnerabilità agli shock esterni. Le crisi recenti hanno mostrato come il risparmio marginale sui costi sia stato più che compensato dall’aumento della volatilità dei prezzi, dalle interruzioni degli approvvigionamenti e dalle perdite di output.
A ciò si aggiunge un elemento cruciale: la dinamica degli investimenti. Nei grandi gruppi globalizzati, l’aumento dei margini non si è tradotto in un corrispondente incremento del capitale produttivo. Una quota crescente dei flussi di cassa è stata destinata alla remunerazione degli azionisti, attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie, piuttosto che agli investimenti in capitale produttivo, infrastrutture e innovazione. Questo squilibrio ha inciso negativamente sulla produttività totale dei fattori e sulla crescita di lungo periodo.
Particolarmente istruttivo è il caso dei servizi di pubblica utilità. La loro trasformazione in public company è avvenuta in settori caratterizzati da monopoli naturali e domanda poco sensibile, con elasticità-prezzo molto basse. In questo contesto, la massimizzazione del valore per l’azionista ha favorito l’estrazione di rendite più che l’efficienza produttiva. Le tariffe sono cresciute più degli investimenti, mentre la qualità dei servizi ha mostrato miglioramenti limitati.
La disciplina del mercato, in assenza di reale contendibilità, è stata sostituita da una regolazione spesso tardiva e incompleta. I regolatori hanno agito prevalentemente ex post, limitandosi a contenere gli eccessi senza incidere sulla struttura degli incentivi. Il rischio operativo è rimasto implicitamente in capo alla collettività, mentre i benefici sono stati privatizzati, configurando un problema strutturale di azzardo morale.
Un ulteriore elemento critico riguarda proprio il ruolo della regolazione economica. Nei mercati liberalizzati ma strutturalmente non contendibili, la regolazione avrebbe dovuto sostituire la concorrenza come meccanismo disciplinante. In realtà, l’intervento regolatorio si è spesso limitato a un controllo formale delle tariffe, senza incidere sulle scelte strategiche di investimento, sulla struttura dei costi e sulla qualità dei servizi offerti. In questo modo, la regolazione non ha corretto le distorsioni del mercato, ma ne ha finito per consolidare gli esiti.
La conseguenza è stata una crescente asimmetria tra rischio e rendimento. Le imprese hanno potuto beneficiare di flussi di ricavi relativamente stabili, grazie alla rigidità della domanda e alla protezione implicita garantita dal quadro normativo, mentre il rischio sistemico è rimasto in capo alla collettività. Questo assetto ha incentivato comportamenti orientati al breve periodo, scoraggiando investimenti di lungo termine e rafforzando una logica di estrazione di rendita piuttosto che di creazione di valore economico e sociale.
Il libero mercato globale ha così prodotto un’economia delle rendite più che della concorrenza. L’allocazione delle risorse è stata guidata dalla massimizzazione dei profitti di breve periodo, non dall’efficienza dinamica né dall’interesse generale. La distanza tra teoria e risultati empirici è ormai evidente. Continuare a difendere questo modello non è una scelta tecnica, ma ideologica, e ignora dati che ne certificano il fallimento strutturale.
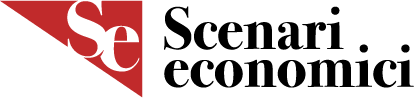
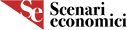






You must be logged in to post a comment Login