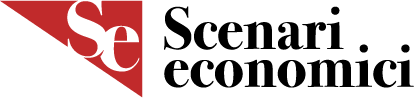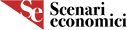Crisi
LA CRISI DELLA GRANDE IMPRESA IN ITALIA (di Alessandro Lelli)
Sarebbe bello ricordare Adriano Olivetti perché è un esempio forte di come si è evoluta, sarebbe meglio dire involuta, la classe dei grandi imprenditori italiani che essendo stati molte volte pionieri nel dopoguerra in tantissimi settori industriali, e avendo creato aziende di grandi dimensioni che hanno portato nel mondo il nostro bellissimo tricolore e i “Made in Italy”, non hanno poi saputo tramandare ad altri le loro grandi capacità creative, non hanno avuto seconde e terze generazioni in grado di mantenere questa leadership di prodotto nella fase della globalizzazione.
Mi si dirà: piccoli imprenditori e non grandi uomini? Probabilmente è così, oppure grandi uomini che non hanno avuto la forza, la volontà e la capacità di cambiare. Forse è proprio questo il termine giusto per definire questa classe imprenditoriale della seconda metà del secolo scorso che è rimasta immutata mentre fuori tutto cambiava e cambiava sempre più velocemente. Eraclito nel VI sec. a.C. diceva “nulla è permanente eccetto il cambiamento” mentre in sintonia, dopo più di 2500 anni, il famoso economista J. M. Keynes era solito dire: “la difficoltà non sta nel credere alle nuove idee ma nel rifuggire dalle vecchie”.
Una classe imprenditoriale che invece di investire in azienda la maggioranza dei profitti, che negli anni d’oro del XX secolo sono stati per molti di loro di livello notevolissimo, ha preferito spesso la finanza e perché no, a volte, anche i paradisi fiscali.
Siamo oggi in una drammatica situazione in cui un grande e bellissimo Paese come l’Italia ha perso quasi tutte le grandi aziende che erano cresciute inizialmente puntando sull’innovazione di prodotto con grandi investimenti in ricerca e sviluppo, sulla capacità di espandersi sui mercati internazionali e, soprattutto, facendo crescere tecnologicamente e culturalmente quell’indotto di PMI che ha contribuito in maniera molto significativa al loro successo; indotto che in seguito allo spegnersi delle grandi imprese, ha dato vita ai distretti industriali che, pur non essendo tipicamente solo italiani, hanno contribuito negli ultimi decenni del secolo scorso al grande successo della nostra industria manifatturiera facendola diventare la seconda in Europa dopo la Germania.
Il problema però resta di dimensioni enormi perché senza validi imprenditori che siano in grado di sviluppare e gestire grandi gruppi industriali viene significativamente a calare quella attenzione alla ricerca che è alla base dello sviluppo delle nuove tecnologie che, avendo bisogno di enormi capitali finanziari, non vengono, o vengono in misura molto ridotta, sviluppate.
Purtroppo in questo contesto il nostro Paese diviene sempre più un Paese di aziende manifatturiere di “commodity” a basso valore aggiunto e quindi facilmente attaccabile dalle economie emergenti e muore lentamente. Ma ritorniamo al cambiamento e alla conseguente carente cultura d’impresa per analizzare quello che non è stato fatto negli ultimi 30 anni e i grandi errori commessi dalla nostra classe imprenditoriale.
Prendo ad esempio alcuni settori dove, a partire dal dopoguerra, la nostra leadership si è via via consolidata ed è stata riconosciuta per decenni a livello mondiale. Parlo del settore automobilistico e motociclistico, dell’agroalimentare, del settore moda, della chimica, dell’acciaio e mi fermo, ma ce ne sarebbero altri.
Quali errori quindi abbiamo compiuto? Prima di tutto non abbiamo sviluppato la cultura di fare impresa che significa crescere culturalmente all’interno dell’impresa più di quanto i mercati chiedano all’impresa stessa.
Significa essere proattivi nel comprendere che, per servire con grandi capacità gestionali un mercato che da locale si amplia gradualmente fino a diventare mondiale, occorre una classe manageriale che non può più essere quella degli anni del boom economico, che sappia trattare a livello globale, che conosca le lingue, le regole del commercio internazionale e le differenti culture. Occorre sviluppare quello che in gergo tecnico si chiama il “cross cultural management ”.
Occorre crescere facendo rete per essere più forti, occorre sapere attrarre il mercato dei capitali per disporre della finanza necessaria, occorre saper fare strategia di prodotto-mercato meglio dei concorrenti, e tant’altro ancora.
Ma noi non abbiamo fatto tutto ciò, o almeno una gran parte della nostra industria non lo ha fatto, e purtroppo ora siamo in cammino verso il deserto della deindustrializzazione.
E’ la cronaca di un Paese in (s)vendita: i gelati Algida, i baci Perugina, lo zucchero Eridania, le bici Atala, le moto Ducati, le auto Lamborghini e molte griffe della moda, purtroppo prodotti così italiani che più italiani non si può, simbolo della cultura e della qualità del Belpaese.
Eppure non sono più italiani da un bel pezzo. Mantengono il marchio, certo, e sono anche fortunati a poterlo fare, perché ci sono altre aziende altrettanto storiche che vengono acquistate da aziende di Paesi stranieri, vengono svuotate dei macchinari e del know-how, e mai riaperte.
E’ la forma più dura di concorrenza, quella che passa attraverso l’eliminazione diretta dell’avversario.
Solo dal 2008 al 2012 sono stati registrati 437 passaggi di proprietà dall’Italia all’estero: i gruppi stranieri hanno speso circa 55 miliardi di euro per ottenere i marchi italiani.
Però le svendite sono cominciate ben prima, già dagli anni ’70 ci sono state le prime acquisizioni. Semmai negli ultimi anni sta cambiando la nazionalità degli acquirenti: prima a fare lo shopping dissennato di brand Made in Italy erano soprattutto aziende della Francia, Stati Uniti, Germania e Regno Unito. In tempi recenti sono arrivati anche imprenditori da Cina, India, Giappone, Corea, Qatar, Turchia e Thailandia.
Il problema non è però tanto da dove arrivino i nuovi padroni. La vera domanda è : si tratta di nuove occasioni, o è l’inizio del declino? La produzione italiana si espande in tutto il mondo o si snatura, lasciando solo macerie della qualità e del benessere del passato? Alcuni imprenditori dichiarano di essere costretti giocoforza a vendere a un prezzo inferiore rispetto a quello reale.
Spesso l’azienda viene delocalizzata, con conseguenze disastrose: perdita di posti di lavoro, di personale specializzato e, inevitabilmente, abbandono degli standard di qualità del prodotto. Il problema è che il modello italiano delle “family business” non regge più.
E’ un modello che presenta una doppia difficoltà: l’accesso al mercato dei capitali, e la successione.
Il modello di padre in figlio non funziona più. E si fa fatica a trovarne uno nuovo: si è esaurita la spinta che aveva consentito alle generazioni precedenti di trasformare un Paese arretrato, agricolo, in una moderna democrazia industriale, sia pure segnata da ritardi e contraddizioni.
E nello stesso tempo, non siamo stati capaci di raccogliere l’eredità, consolidarne i risultati e utilizzarli come piattaforma per il raggiungimento di nuovi traguardi, per la messa a punto di un nuovo progetto. Abbiamo pensato, stoltamente, che si potesse vivere di rendita all’infinito in un mondo in continuo mutamento.
Tutto quanto detto vale a livello generale ma ha anche fortunatamente delle rilevanti eccezioni che indicano quale possa essere la strada giusta.
E anche lo Stato deve fare la sua parte non certo aprendo una nuova stagione assistenzialista, quanto rendendo più efficiente la rete di servizi frammentata e autoreferenziale, che pure esiste a livello centrale e periferico, attraverso una profonda riforma che ne riqualifichi la prospettiva.
Si può solo aggiungere che se è vero che lo Stato ha le sue tante responsabilità l’Impresa ne ha altrettante. Questo non giustifica però nient’affatto le inefficienze di tutti i Governi che si sono susseguiti negli ultimi quarant’anni, dopo il boom economico, che non hanno mai operato con precise strategie di sviluppo dell’impresa Italia per definire, come sarebbe stato necessario, le linee guida per l’evoluzione industriale e non hanno mai lavorato in un’ottica di semplificazione burocratica e fiscale che permettesse alle imprese di diventare sempre più competitive, anzi hanno sempre agito per peggiorare le condizioni rendendo il terreno su cui operano le nostre imprese sempre più complicato e fiscalmente troppo pesante.
Ma non giustifica neanche chi ha gestito il passaggio all’euro con tutti gli effetti negativi che dall’ora in poi sono arrivati sulle imprese italiane micro, piccole, medie e grandi dall’ingresso dell’Italia nella moneta unica che ci ha messo in una condizione di competitività praticamente impossibile.
Era chiaro sin dall’inizio, ai registi di questa grande operazione valutaria, che l’unico obiettivo che si voleva raggiungere, includendo Paesi enormemente diversi in una unione monetaria, era quello di ridurre i salari e lo stato sociale senza grandi opposizioni al grido di “ce lo chiede l’Europa”; quindi l’unica via percorribile per evitare guai maggiori rimediando così, con i compiti a casa, agli errori del passato.
Errori a cui avremmo potuto comunque rimediare, mantenendo però la nostra sovranità, con una classe politica più onesta e preparata. Nel settore industriale di cui parliamo tutto ciò ha portato a fallimenti a catena, specialmente nelle micro-piccole imprese, con la perdita di un quarto della nostra capacità industriale dal 2008 ad oggi.
Perdita che ha fatto certamente molto comodo alla Germania visto che in questa situazione, e ogni giorno di più, la nostra capacità di concorrere si riduce mentre con un cambio “flessibile” avremmo invece creato grossi problemi alle aziende teutoniche.
Probabilmente alcuni imprenditori, con costi di produzione più bassi, stanno reagendo alla crisi ma se guardiamo il Paese nella sua globalità il risultato è stato disastroso: tra disoccupati e scoraggiati siamo alla soglia del 28%.
Solo chi lavora principalmente con le esportazioni, ma pochi sanno che queste aziende sono circa 200.000 e quindi solo il 4,5% del totale imprese italiane (circa 4,4 milioni di imprese), è riuscito a sopravvivere meglio del restante 95,5% che ogni giorno deve decidere se continuare a lottare in una situazione sempre più difficile o chiudere i battenti.
E’ esattamente quello che sta succedendo ormai da troppo tempo, e sotto gli occhi di tutti o quasi, ma chi ne parla più? Forse varrebbe la pena che gli imprenditori lo capissero e si svegliassero prima di essere tutti morti.
Chiudo ricordando solo che, pur in una situazione di grande difficoltà quale quella attuale, si potrebbe di nuovo garantire lo sviluppo delle imprese ritornando alla nostra sovranità nazionale e chiedendo però nello stesso tempo agli imprenditori ancora in essere di continuare ad investire i loro profitti in azienda per essere sempre più competitivi e leader sui mercati mondiali ; si può e si deve ritornare ad essere un Paese di micro-piccole-medie, e soprattutto grandi imprese, ma affinché tutto ciò si avveri occorre una classe imprenditoriale che sappia guardare lontano e Governi che governino facendo solamente l’interesse degli italiani.
Alessandro Lelli
(*) Imprenditore e consulente di strategia e organizzazione, Professore a contratto alla facoltà di Economia dell’Università di Bologna.
Nota di Scenarieconomici.it: ospitiamo Alessandro Lelli con piacere e vi proponiamo questo suo pezzo assolutamente interessante. Ci auguriamo di poter proporre anche in futuro altri suoi articoli.