Attualità
A chi conviene fare la guerra? di C.A. Mauceri

Gli ultimi decenni non sono stati un periodo di “pace” come si vorrebbe far credere. Nel mondo si stanno combattendo decine e decine di guerre e altri conflitti armati. Alcuni tra paesi altri all’interno dei confini di un singolo stato. Oggi, tra gli esperti non c’è nemmeno una condivisione su cosa si debba intendere per “guerra”. È per questo che molte guerre non sono nemmeno considerate tali. Anche quando i loro combattimenti vanno avanti da decenni: come nel caso della guerra in Myanmar o di quella tra India e Pakistan o di quella tra israeliani e palestinesi.
Unico aspetto che da sempre accomuna queste guerre è che alla basi ci sono sempre grossi interessi economici. Un tempo questi interessi erano legati esclusivamente alle risorse del territorio conteso. Da qualche decennio però, molti governi hanno capito che “fare la guerra” è diventato un affare estremamente redditizio. Il giro d’affari legato alla produzione di armi e armamenti ha raggiunto dimensioni spaventose. A questo si aggiungono i vantaggi per i paesi vincitori di poter gestire la ricostruzione dei territori devastati. Si pensi agli
Buona lettura
Alessandro Mauceri
A chi conviene fare la guerra?
Che cosa significa “guerra”?
Secondo alcuni, gli ultimi decenni sarebbero stati un periodo di “pace”. Forse confrontandoli con le guerre “mondiali” che hanno caratterizzato la prima metà del XX secolo. Oggi nei paesi occidentali non si ha la sensazione di essere in guerra. Eppure sono decine le guerre in corso. E molte di queste coinvolgono, direttamente o indirettamente, i paesi occidentali.
Prima si parlava sempre della guerra in Afganistan. Da un anno, si parla solo della guerra in Ucraina. Ma non sono queste le uniche guerre che si sta combattendo. Il problema potrebbe nascere da cosa si intende con il termine “guerra”. Di certo non ci si può basare sulla “dichiarazione di guerra”. Questo è un atto formale la cui origine risalirebbe addirittura al Rinascimento, quando furono emesse le prime dichiarazioni di guerra. Si tratta di un passaggio Una dichiarazione formale potrebbe consentire al paese attaccato di arrendersi prima che inizino gli scontri, che si sparga del sangue. Ma anche prima che vengano chiusi i confini, cessino i rapporti commerciali e siano espulsi gli oppositori (tutte azioni normali in caso di guerra). Ma non basta. La dichiarazione di guerra sarebbe un annuncio a paesi terzi che sta per avere luogo un conflitto. Questo darebbe modo agli altri paesi di decidere se rimanere neutrali o schierarsi e con chi. Soprattutto, la dichiarazione di guerra dovrebbe racchiudere in sé le condizioni per cui le ostilità possano cessare. Nel 1919, dopo la creazione della Società delle Nazioni (oggi Organizzazione delle Nazioni Unite), venne introdotto un nuovo modo di considerare la guerra nel quadro delle relazioni tra stati. La Carta delle Nazioni Unite, infatti, ha stabilisce espressamente per gli Stati membri, il divieto di usare la forza nelle relazioni internazionali, vietandone anche la semplice minaccia nei confronti dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica di un altro Stato. Unica eccezione l’ipotesi della legittima difesa e il ricorso all’uso della forza deliberato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (1) In Italia, la dichiarazione di guerra è un atto di competenza del Presidente della Repubblica, a norma dell’art. 87 comma 9 della Costituzione. Da non confondere la dichiarazione di guerra con la deliberazione dello stato di guerra, che spetta all’organo legislativo, come previsto dall’art 78 della Costituzione: “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.”
Eppure, da oltre mezzo secolo, le guerre che si sono combattute e che sono in corso in questo momento, solo iniziate senza alcuna dichiarazione formale. Cominciano con un attacco violento. A volte prevedibile altre volte meno, ma mai con una dichiarazione formale inviata seguendo “regole” concordate (ma mai rispettate). Allo stesso modo, spesso non si può parlare della fine di una guerra partendo dalla fine degli scontri: sono molte le guerre che si combattono da decenni seppure con alti e bassi. Spesso ai periodi di pace, che a volte durano anni, seguono nuovi bagni di sangue.
Come capire allora se un paese è in “guerra”? L’OxfordEnglish Dictionary cerca di dare diverse definizioni di cosa si dovrebbe intendere per “guerra”. Può essere uno stato di conflitto armato tra diversi paesi o diversi gruppi all’interno di uno stesso paese. Oppure, può trattarsi di uno stato di ostilità tra persone o gruppi diversi. O ancora di azioni violente sostenute contro una situazione o un’attività indesiderabile. (8) Alcuni cercano di dare una definizione della guerra partendo dalle motivazioni che sono alla base degli scontri. A ben guardare, però, tutte lo guerre, sia quelle del passato che, a maggior ragione, quelle attuali sono riconducibili a pochi motivi. Quasi sempre si tratta di interessi economici o legati al controllo del territorio e all’accaparramento di risorse naturali o energetiche. Oppure a pressioni demografiche o a cambiamenti climatici. Molte volte, i veri motivi che spingono a combattere una guerra sono nascosti. Dietro motivazioni religiose o forme di nazionalismo o ragioni politiche. O, più di recente, alla volontà di “tutelare” i diritti di un popolo. Altre volte, sono i leader politici i principali promotori dei conflitti: sono loro a istigare le dispute territoriali, interne o esterne. In alcuni casi, conflitti “armati”semplicemente non vengono classificati come “guerre”.
Per cercare di risolvere a questo problema, l’UCDP, l’Uppsala Conflict Data Program, ha suggerito di utilizzare un parametro quantitativo per definire quando questi scontri dovrebbero essere definiti “guerra”: “un conflitto o diade basato sullo stato che raggiunge almeno 1.000 morti legate alla battagliain uno specifico anno solare”, includendo in questo numero sia i combattenti uccisi in azione che i civili deliberatamente uccisi (ad esempio, da bombardamenti o altri attacchi). (2) L’Uppsala Conflict Data Program, però, va oltre. Suddivide i conflitti in tre tipologie. Prima di tutto, ci sarebbero i cosiddetti State-based armed conflict, ossia quei conflitti dove si registra una posizione incompatibile tra uno Stato e l’altro o nei confronti di un’altra organizzazione. Poi, ci sono i non-State conflict, cioè quei conflitti che vedono coinvolte organizzazioni e bande armate locali. Infine, le cosiddette one-sided violence, ossia quelle forme di violenza, quegli attacchi unilaterali perpetuati da uno stato o da un’organizzazione armata nei confronti dei civili.
Nonostante gli sforzi dei ricercatori per definire cosa si dovrebbe intendere per “guerra” (in assenza di dichiarazioni formali), le risposte al quesito “quante guerre sono in atto in questo momento nel mondo?” restano diverse. A volte molto diverse tra loro. Secondo alcuni, sarebbero poco più di venti. Secondo altri, in questo momento, sarebbero ben 170 i conflitti in corso, intendendo con il termine “conflitto” non solo quei contesti dove gli eserciti di due paesi si fronteggiano su ampia scala, ma anche gli scontri armati di diversa intensità che possono coinvolgere a vario titolo stati, organizzazioni criminali e fazioni o la popolazione civile.
In mancanza di una formale “dichiarazione di guerra”, come è possibile capire se è quando ci sta avviando verso una guerra? Secondo Stuart Bremer esistono quattro “war predictors”, quattro fattori che possono indicare che si è vicini all’inizio di una guerra. Eventi che possono costituire un campanello d’allarme e far comprendere che, da lì a poco, lo scontro verbale e diplomatico potrebbe diventare conflitto armato. Spesso sono segnali che riguardano le dispute territoriali; oppure la stipula di accordi e alleanze che possono inasprire oppure distendere i rapporti tra stati (esemplare il caso dell’Ucraina e della promessa di entrare a far parte della Nato); o ancora possibili situazione di insicurezza dovuta alla corsa agli armamenti; anche la presenza di instabilità domestica, a volte, può condurre alla deflagrazione in guerre diversive contro un nemico esterno.
Le guerre in questo momento
Partendo da questi “segnali” (e dalle definizioni viste prima), secondo l’UCDP, in questo momento, nel mondo, sarebbero in atto 54 State-based violence,76 non-State conflict e 40one-sided violence.
Il caso del conflitto in Ucraina è sotto diversi aspetti esemplare. La guerra non è iniziata nel 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il suo inizio sarebbe da far risalire almeno al 2014, quando la Russia decise di annettere la penisola ucraina di Crimea. Anche la guerra in Ucraina sarebbe iniziata senza alcuna dichiarazione formale di guerra: dopo aver riconosciuto ufficialmente le regioni separatiste ucrainedi Donetsk e Luhansk, il 21 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le proprie truppe in Ucraina. In poche ore, quella che lui stesso ha definito una missione di “mantenimento della pace”è diventata un’invasione su larga scala. Un conflitto al quale partecipano direttamente o indirettamente, decine di nazioni. Ma tutti in modo indiretto. La speranza, nemmeno troppo nascosta, di Putin era realizzare una guerra lampo: il 25 febbraio 2022, le forze russe avevano raggiunto l’aeroporto vicino a Kiev e molti pensavano che in pochi giorni (se non ore) avrebbero preso il controllo della capitale.Purtroppo ogni volta che un leader ha pensato di risolvere un conflitto armato in pochi giorni, ha fallito miseramente. SI pensi alla guerra in Afganistan. O a quella in Libia. Lo stesso è avvenuto con l’invasione dell’Ucraina. A distanza di oltre un anno, la guerra tra Russia e Ucraina è tutt’altro che finita. Da un lato, all’Ucraina non sono bastate le misure economiche contro la Russia da parte di molti paesi occidentali. Nè gli aiuti umanitari, l’accoglienza dei profughi e dei rifugiati e le montagne di armi e armamenti provenienti da molti paesi alleati. Dall’altro, alla fine del 2022, la Russia si è impantanata (letteralmente) nel terreno ghiacciato che, scongelandosi, è diventato fangoso e paludoso e ha limitato la capacità operativa di carri armati e altri veicoli corazzati pesanti. Secondo alcuni, i russi starebbero incontrando difficoltà a mantenere le linee di rifornimento. Un fattore importante: secondo alcuni rapporti, le forze di terra russe erano entrate in Ucraina accompagnate da forniture di carburante e rifornimenti vari per un periodo di tempo limitato. Sarebbe questo il motivo per cui molti carri armati russi sono stati abbandonati senza essere stati colpiti: per aver finito il carburante.
L’attenzione dedicata dai media alla guerra in Ucraina ha fatto passare in secondo piano molte altre guerre. Come quella in Myanmar. Anche in questo caso le origini del conflitto sono lontane nel tempo: risalirebbero addirittura al 1948, anno in cui il paese ha ottenuto l’indipendenza
dal Regno Unito. Da allora, gli scontri sono continuati sebbene con momenti di stallo più o meno lunghi. Oggi, questa guerra è tra le più “vecchie” al mondo. Dal 2011 al 2021, gli scontri sembravano essere diminuiti. Poi, nel 2021, un nuovo colpo di stato militare ha fatto ripiombare il paese in un vortice di violenza. Si stima che, solo nei primi otto mesi del 2022, le vittime sono state quasi 14mila. Secondo il rapporto del gruppo di monitoraggio ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) solo nei primi sei mesi del 2022 gli eventi violenti condotti dall’esercito contro i civili sarebbero stati almeno 668, circa il doppio rispetto a quelli avvenuti in Afghanistan nello stesso periodo. (3)
Fig. 1 – Guerra in Myanmar
Del conflitto in Myanmar si è parlato soprattutto in relazione agli eventi che hanno riguardato Aung San Suu Kyi, ex leader politico, prima incarcerata, poi al governo, poi di nuovo in carcere. Recentemente la leader pacifista è stata condannata dal regime a 17 anni di prigione. Nel 1991 le era stato concesso il premio Nobel per la Pace seguito da una quantità impressionante di riconoscimenti in tutti i continenti. Ora il premio Nobel per la Pace e molte delle onorificenze che le erano state conferite sono state ritirate. La causa sarebbe da ricercare nel suo comportamento e nei rapporti (inizialmente di convivenza) con il regime militare. Tra le colpe attribuite alla San Suu Kyi non aver fatto molto per fermare la persecuzione dei Rohyinga.
Anche in questo caso, come in molti altri, dietro il conflitto ci sono enormi interessi economici. Pochi mesi fa, il Consiglio Consultivo Speciale sul Myanmar, formato da ex alti funzionari delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto nel quale si parla degli affari realizzati da grandi aziende di paesi stranieri – anche occidentali – per la fornitura di armi leggere al regime dittatoriale. Aziende con sedi in Israele, in Cina, a Singapore, in India, in Giappone, in Corea del Sud, in Corea del Nord, in Russia, ma anche in Francia, in Austria, in Germania e perfino in Ucraina. Queste imprese avrebbero fornito ai vertici del regime militare macchinari, software e materie prime poi utilizzati per produrre armi da usare all’interno del paese. Durissimo il giudizio di Yanghee Lee, ex relatore speciale ONU sui diritti umaninel Paese asiatico, di Chris Sidoti e Marzuki Darusman, tutti membri della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite sulla ex Birmania. “Le aziende straniere permettono all’esercito del Myanmar – uno dei peggiori violatori dei diritti umani al mondo – di produrre molte delle armi che utilizza per commettere atrocità quotidiane contro il popolo del Myanmar”, ha dichiarato Yanghee Lee. Purtroppo le sue dichiarazioni non hanno scatenato la stessa reazione nata per il conflitto in Ucraina. Nè sui media né sui governi.
Altro paese, altra guerra. In Sudan, gli scontri tra l’esercito e la principale forza paramilitare del paese continuano a causare un numero impressionante di morti. Apparentemente la causa degli scontri sarebbe da ricercare nella disputa per il potere tra due fazioni militari sudanesi. Da un lato, le Forze armate sudanesi, fedeli al generale Abdel Fattah al-Burhan, per molti anni sovrano de facto del Sudan. Dall’altro i paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF), milizie fedeli al generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. Create per contrastare i ribelli in Darfur in rivolta per decenni a causa dell’emarginazione politica ed economica della popolazione locale voluta dal governo centrale, nel 2013, i Janjaweed sono diventati una forza paramilitare semi-organizzata. Molti miliziani sono stati inviati a combattere in Yemen o in Libia. Note con il nome di Janjaweed, le RSF sono state accusate di molte atrocità. Le RSF sono state accusate di aver attaccato un sit-in pacifico di fronte al quartier generale militare a Khartoum, uccidendo centinaia di persone.
Fig. 2 – Guerra in Sudan
Dopo anni di scontri, era stato raggiunto un accordo che prevedeva la condivisione dei poteri con i civili che avevano guidato le proteste contro Bashir. Ma nell’ottobre 2021 un colpo di stato ha interrotto il cammino che avrebbe dovuto portare ad un governo democratico. L’esercito è tornato al comando. Da allora deve affrontare proteste un rinnovato isolamento e notevoli problemi economici. Più volte Hemedti ha parlato di un piano per la pace, ma l’unico risultato è stato un inasprimento delle tensioni. Il suo potere deriva infatti dall’enorme ricchezza personale legata all’esportazione di oro dalle miniere illegali. La parte non militare che sarebbe dovuta salire al governo ha più volte chiesto di rinunciare alle lucrose partecipazioni militari in diversi settori: agricoltura, commercio e industria. Una fonte di ricchezza e potere che ha permesso all’esercito di esternalizzare l’azione militare.
Altro punto di contesa è la ricerca della giustizia sulle accuse di crimini di guerra da parte dell’esercito e dei suoi alleati nel conflitto in Darfur dal 2003. Lo scorso anno, una rivolta popolare ha deposto Omar al-Bashir. É stato arrestatoper corruzione e rinviato a processo per il colpo di stato militare che lo ha portato al potere più di tre decenni fa (potrebbe essere condannato alla pena di morte per il golpe del 1989 contro il governo democraticamente eletto del premier Sadek al-Mahdi). L’uomo considerato il vero ideatore del golpe, Hassan al Turabi, è morto nel 2016. Dopo anni di isolamento totale, il Sudan continua a dover affrontare molti problemi. Secondo la FAO e il WFP è fra i paesi più a rischio di crisi alimentare per le conseguenze della pandemia.
Su Bashir pende anche il rinvio a giudizio della Corte penale internazionale (per quella di Putin si è parlato a lungo di questa quasi mai): è accusato di crimini di guerra e genocidio durante il conflitto in Darfur, dove sarebbero state uccise 300.000 persone (e dove sono milioni gli sfollati). Ma cosa c’è davvero dietro la guerra in Sudan? Qual’è il vero motivo di tutti questi scontri? Il Sudan si trova in una area instabile che confina con il Mar Rosso, con la regione del Sahel e con il Corno d’Africa. Una posizione strategica dal punto di vista geopolitico ma, soprattutto, un territorio ricchissimo sia in termini di produzione agricola che di risorse minerarie. Entrambe da sempre fanno gola a molti. È questo che, per decenni, ha reso quasi impossibile una transizione verso un governo guidato da civili. Molti dei paesi confinanti con il Sudan – tra cui Etiopia, Ciad e Sud Sudan – sono stati colpiti da sconvolgimenti politici e conflitti. Le relazioni del Sudan con l’Etiopia, in particolare, sono state incentrate sui terreni agricoli contesi lungo il confine. In gioco c’è anche l’influenza geopolitica esercitata da paesi come Russia, Stati Uniti d’America, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e altri che fanno di tutto per acquisire il potere di esprimere la propria influenza sul Sudan. I sauditi e gli Emirati Arabi Uniti in particolare, insieme agli Stati Uniti d’America e alla Gran Bretagna, formano il “Quad”, che ha sponsorizzato la mediazione in Sudan insieme alle Nazioni Unite e all’Unione Africana.
Quelli appena visti sono solo alcuni esempi di guerre in atto in questo momento. L’elenco completo sarebbe lunghissimo. In tutti i continenti si combattono guerre. Come i 76 non-State conflict che includono gli scontri armati tra i cartelli della droga messicani,quelli tra varie organizzazioni criminali in Brasile e quelli tra le varie etnie e gruppi religiosi in diversi paesi dell’Africa. E poi i 40 one-side violence: tra questi si contano le violenze esercitate da vari governi verso i civili, come quelle dei talebani in Afghanistan o, più recentemente, quelle perpetrate dal governo iraniano sui manifestanti scesi in piazza per protestare in seguito alla morte di Mahsa Amini.
Le conseguenze di queste guerre
I dati riportati dall’International Rescue Committee nella Emergency Watchlist sono preoccupanti. Oggi, più di 100 milioni di persone sono in fuga da conflitti e disastri. Si prevede che, entro il 2023, saranno almeno 340 milioni le persone che avranno bisogno di assistenza umanitaria a causa di conflitti armati. Il report annuale sui conflitti in atto nel mondo è più di un avvertimento: i ricercatori forniscono suggerimenti su come evitare o ridurre al minimo tali crisi umanitarie. (4)
I 20 paesi della Watchlist 2023 ospitano solo il 13 per cento della popolazione mondiale e rappresentano solo l’1,6 per cento del PIL globale, ma rappresentano l’81 per cento degli sfollati forzati, l’80 per cento delle persone che affrontano crisi o livelli catastrofici di insicurezza alimentare e il 90 per cento del bisogno umanitario globale. Guidati da Somalia, Etiopia e Afghanistan, i 20 paesi che formano la Watchlist 2023 sono un chiaro esempio delle sfide che devono affrontare le comunità fragili e colpite dalla crisi in tutto il mondo. Alla crisi climatica e alle turbolenze economiche si sono aggiunti i conflitti armati che stanno spingendo parte della popolazione mondiale in una crisi sempre più profonda. Somalia e dall’Etiopia entrambi paesi ai vertici della Watchlist: anni di conflitto hanno ridotto la capacità di entrambi questi paesi di resistere ad eventi estremi, crisi climatiche e siccità record.
Importanti gli effetti negativi delle guerre anche a migliaia di chilometri di distanza. Ad esempio, l’invasione dell’Ucraina per mano della Russia (così come l’impatto a lungo termine della pandemia di COVID-19) hanno causato il malfunzionamento delle catene di approvvigionamento dei prodotti alimentari e una variabilità dei prezzi che ha determinato una insicurezza alimentare i cui effetti sono stati rilevanti anche in zone lontane. I paesi della Watchlist hanno sperimentato conflitti armati per una media di 12 anni: guerre che hanno devastato infrastrutture, strutture locali e mezzi di sussistenza e servizi da cui le comunità dipendono per resistere agli shock di vario genere (economico, stagionale, climatico e altri). Si pensi al conflitto in Siria o nello Yemen: molti dei rifugiati in fuga da questi paesi scappano non a causa della guerra in senso diretto ma a causa della impossibilità di vivere in un territorio martoriato dagli scontri.
L’importanza di mettere insieme i dati su guerre e crisi umanitarie rilevati dalla Watchlist deriva dal fatto che questo confronto consente di capire perché si rischia di non essere più in grado di gestire queste emergenze. Le cause sono l’indebolimento globale fuori misura e, in certi casi il completo smantellamento di alcune barriere, i “guardrail”, creati in passato per evitare che le crisi umanitarie potessero diventare incontrollabili.
Tutto questo è strettamente legato alle guerre. Nel 2022, la tregua di sei mesi mediata dalle Nazioni Unite nello Yemen ha portato a un calo del’86 per cento delle vittime – un “guardrail” che con la scadenza della tregua rischia di cadere. Lo stesso dicasi per l’accordo (a guerra in corso) sui cereali ucraini che ha permesso di esportare oltre 12 milioni di tonnellate di cibo attraverso il Mar Nero: un’ancora di salvezza per i paesi a basso e medio-basso reddito già in difficoltà a causa degli effetti della crisi alimentare globale. É bene sottolineare che nessuno di questi eventi ha posto fine alle crisi. Ha solo impedito che diventassero catastrofi.
La portata e la natura dei conflitti, al contrario, a volte sovraccarica le barriere e rende le crisi umanitarie incontrollabili. E gli aiuti non sono più in grado di fronteggiare le emergenze e le criticità del momento. La Watchlist 2023 mostra che è necessario un drastico cambiamento nel modo di relazionare le crisi umanitarie con i conflitti armati e le guerre. Fondamentale proteggere i civili coinvolti nei conflitti. Ristabilire il diritto dei civili all’aiuto attraverso l’intervento di organizzazioni indipendenti (come l’Organizzazione per la promozione dell’accesso umanitario), in grado di documentare la necessità di aiuto.
Vendita armi e armamenti
Inutile dire che per combattere le guerre servono armi e armamenti. Tante armi. E poi munizioni, attrezzature militari e molto altro ancora. Ogni anno sempre di più. Negli ultimi anni la spesa militare globale è aumentata ad un ritmo impressionante. Il 2022 è stato il settimo anno consecutivo in cui la spesa ha mostrato un trend crescente. “Anche in mezzo alle ricadute economiche della pandemia di COVID-19, la spesa militare mondiale ha raggiunto livelli record”, ha dichiarato Diego Lopes da Silva, ricercatore senior del programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. “C’è stato un rallentamento del tasso di crescita in termini reali a causa dell’inflazione. In termini nominali, tuttavia, la spesa militare è cresciuta del 6,1 per cento”.
Come risultato di una forte ripresa economica nel 2021, l’onere militare globale – spesa militare mondiale in quota del Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale – è diminuito di 0,1 punti percentuali, dal 2,3 per cento nel 2020 al 2,2 per cento nel 2021. Questo non ha impedito, nel 2021, di raggiungere i 2.113 miliardi di dollari di spesa. I cinque paesi maggiori responsabili di questa spesa sono Stati Uniti, Cina, India, Regno Unito e Russia: insieme rappresentano il 62 per cento della spesa in armi e armamenti, secondo i nuovi dati sulla spesa militare globale pubblicati dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI).
Il paese che spende di più (e di gran lunga) in armi e armamenti sono gli Stati Uniti d’America. Nel 2021, la spesa militare degli USA ha raggiunto la stratosferica somma di 801 miliardi di dollari. Per i contribuenti americani, l’onere militare degli Stati Uniti d’America è pari al 3,5 per cento del PIL, nel 2021. Tra il 2012 e il 2021, negli USA, anche i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo militare (R&S) sono aumentati: addirittura del 24 per cento. “L’aumento della spesa in R&S nel decennio 2012-21 suggerisce che gli Stati Uniti si stanno concentrando maggiormente sulle tecnologie di prossima generazione”, ha affermato Alexandra Marksteiner, ricercatrice del Programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. “Il governo degli Stati Uniti ha ripetutamente sottolineato la necessità di preservare il vantaggio tecnologico dell’esercito americano rispetto ai concorrenti strategici”.
Anche la Russia ha aumentato il proprio bilancio militare in vista della guerra. Nel 2021, le sue spese militari sono aumentate del 2,9 per cento, fino a 65,9 miliardi di dollari. Anche in questo caso, non è stato un evento una tantum: era il terzo anno consecutivo di aumento della spesa militare sul bilancio nazionale. Rilevante il carico sul PIL: nel 2021, la spesa in armi e armamenti in Russia ha raggiunto il 4,1 per cento del PIL. “Le elevate entrate di petrolio e gas hanno aiutato la Russia ad aumentare le sue spese militari nel 2021. Le spese militari russe sono diminuite tra il 2016 e il 2019 a causa dei bassi prezzi dell’energia combinati con le sanzioni in risposta
all’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014”, ha dichiarato Lucie Béraud-Sudreau, direttore del programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. La linea di bilancio della “difesa nazionale”, che rappresenta circa i tre quarti della spesa militare totale della Russia e comprende finanziamenti per i costi operativi e l’approvvigionamento di armi, è stata rivista al rialzo nel corso dell’anno. La cifra finale è stata il 14 per cento in più rispetto a quanto preventivato alla fine del 2020.
Anche la spesa militare dell’Ucraina è aumentata. Dall’annessione della Crimea, nel 2014, l’Ucraina ha rafforzato le sue difese contro la Russia. Recentemente, però, questo aumento ha avuto una impennata impressionante: nel 2021, la spesa in armi e armamenti è aumentata del 72 per cento e ha raggiunto il 3,2 per cento del PIL del paese.
In termini assoluti, il secondo paese al mondo per spesa in armi e armamenti è la Cina. Nel 2021, ha stanziato circa 293 miliardi di dollari per le forze armate. Ancora una volta, rilevante l’aumento (4,7 per cento) rispetto all’anno precedente. In Cina, la spesa per armi e armamenti aumenta ininterrottamente da 27 anni.
Il terzo paese al mondo per fondi destinati alla spesa militare è l’India, con 76,6 miliardi di dollari. Anche in questo caso si è registrato un aumento (dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente e del 33 per cento rispetto al 2012).
In quasi tutti i paesi sviluppati e industrializzati le somme destinate ad armi ed armamenti sono aumentate. In Giappone, dopo l’approvazione iniziale del bilancio 2021, il governo ha aggiunto 7,0 miliardi di dollari alla spesa militare. Di conseguenza, per quell’anno, la sua spesa in armi e armamenti è aumentata del 7,3 per cento, fino alla considerevole somma di 54,1 miliardi di dollari. È l’aumento annuale più alto dal 1972. Nel 2021, anche la spesa militare australiana è aumentata e ancora una volta in modo notevole: del 4,0 per cento, per un totale di 31,8 miliardi di dollari. Tra i paesi dell’Europa centrale e occidentale, la Germania è il terzo per spesa in armi e armamenti: ha destinato 56,0 miliardi di dollari a questa voce di spesa nel 2021, ovvero l’1,3 per cento del proprio PIL (una percentuale leggermente inferiore all’1,4 per cento rispetto al 2020 ma dovuta principalmente all’inflazione).
Nel 2016, il presidente degli Stati Uniti d’America Trump invitò formalmente tutti i paesi membri dell’Organizzazione europea del Trattato del Nord Atlantico (NATO) a tenere fede al proprio impegno che prevedeva di destinare almeno il 2 per cento del proprio PIL nazionale alle loro forze armate. Nel 2014, solo due paesi avevano raggiunto questa soglia. Nel 2021, erano otto i paesi ad aver raggiunto l’obiettivo dell’Alleanza. Uno in meno rispetto al 2020.
“La crescente assertività della Cina dentro e intorno ai mari della Cina meridionale e orientale è diventata uno dei principali motori della spesa militare in paesi come l’Australia e il Giappone”, ha affermato la dott.ssa Nan Tian, ricercatrice senior del SIPRI. “Un esempio è l’accordo di sicurezza trilaterale AUKUS tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti che prevede la fornitura di otto sottomarini a propulsione nucleare all’Australia ad un costo stimato fino a 128 miliardi di dollari”. (5)
Nel 2021, la spesa militare del Qatar è stata di 11,6 miliardi didollari: è il quinto paese per spesa in armi e armamenti in Medio Oriente. Negli ultimi anni, in Qatar si è avuto un cambiamento radicale. Ci si è resi conto che non c’era solo il petrolio come fonte di ricchezza. Anche comprare e rivendere armi e armamenti era un settore lucrativo.Secondo gli ultimi dati, a spesa militare del paese nel 2021 è stata superiore del 434 per cento rispetto al 2010, ovvero da quando il paese ha pubblicato i dati.
Per strano che possa apparire anche paesi tutt’altro che ricchi e con grossi problemi interni hanno destinato grandi somme all’acquisto di armi e armamenti. Nel 2021, per la prima volta in quattro anni, il bilancio militare iraniano è aumentato fino alla considerevole somma di 24,6 miliardi di dollari. Anche la Nigeria ha aumentato la sua spesa militare. Lo ha fatto in modo radicale: +56 per cento nel 2021, per raggiungere i 4,5 miliardi di dollari. Una decisione la sua giustificata con la necessità di essere in grado di rispondere a numerose sfide alla sicurezza come l’estremismo violento e le insurrezioni separatiste.
A cosa servono tutte queste armi?
Qual è il vero motivo di questa spesa enorme e sempre più elevata in armi e armamenti? La risposta potrebbe essere ovvia: non per “difendersi”, ma per combattere guerre. Ma questo non fa che portare ad una nuova domanda: perché nel mondo si combattono così tante guerre?
Come si diceva all’inizio, da sempre la causa principale che porta a combattere una guerra sono gli interessi economici: accaparrarsi il controllo di un certo paese o di un territorio o delle sue risorse naturali e strategiche. A questa motivazione, però, da qualche decennio se ne è aggiunta un’altra: i paesi maggiori costruttori di armi hanno capito che “fare la guerra” è un affare multimiliardario. Tutti i paesi che dispongono di un esercito, di armi, armamenti e attrezzature, dopo un certo periodo sono costretti a sostituirli per evitare che diventino obsoleti. Ammodernare i propri arsenali è prioritario. Fino a qualche anno fa, la prassi era vendere o svendere queste armi a paesi poveri o meno sviluppati per ricavare qualche soldo da destinare alle nuove armi sempre più evolute ed efficaci da inserire nel proprio arsenale. La conferma viene dalla politica adottata dal maggior produttore di armi al mondo. Per decenni gli Stati Uniti d’America hanno combattuto guerre e missioni di pace in vati paesi. Poi hanno capito che il costo in termini di vite umane (e di immagine visto che non sempre hanno vinto, anzi) non giustificava più queste guerre. Hanno compreso che, per loro, sarebbe stato molto più conveniente vendere queste armi ad altri paesi coinvolti in queste guerre (si pensi all’enorme quantità di armi vendute all’Arabia Saudita e ad altri paesi mediorientali). Più di recente , però, le crisi economiche che hanno colpito molti paesi meno sviluppati hanno reso anche questo modo di fare meno vantaggioso di prima. E allora i paesi sviluppati hanno dovuto trovare un altro modo per giustificare la produzione e l’acquisto di armi sempre più sofisticate.
Con un passaggio che può sembrare poco importante ma che è, invece, fondamentale, si è passati dal considerare la decisione di comprare sempre più armi e armamenti non più una scelta politica (e quindi discutibile e opinabile), ma una necessità (e, quindi, irrinunciabile). Esemplare, ancora una volta, il caso della guerra in Ucraina. Tutti i paesi occidentali (nessuno escluso) si sono precipitati a inviare, a “regalare” armi e armamenti all’Ucraina per consentirle di “difendersi” dall’invasore russo (ma non prima della promessa di poter avere una fetta nella ricostruzione del paese a guerra finita: il numero di viaggi compiuti dai leader occidentali in Ucraina da febbraio 2022 ad oggi è senza precedenti). Questo ha consentito ai governi occidentali di svuotare i propri arsenali pieni di armi ormai quasi obsolete. Mesi fa, Zelensky ha dichiarato pubblicamente che il materiale consegnato da una forza alleata “non ha funzionato in combattimento”. Ad andare più a fondo è stato il Financial Times che ha parlato di alcuni cannoni semoventi M109L “donati” dall’Italia all’Ucraina ma di fatto “inutilizzabili”.
Sull’altro fronte, in Italia, alti ufficiali dello Stato maggiore hanno lanciato l’allarme dicendo che, in queste condizioni, se il paese venisse attaccato, “la capacità di resistenza sarebbe valutata tra le 48 e le 72 ore”. Questo ha “costretto” i governi (più di uno) a comprare nuove armi. Il ministro Crosetto ha sottolineato che “le esigenze di difesa nazionale impongono la disponibilità di scorte adeguate”. E a marzo, nel corso di un question time alla Camera dei deputati, ha spiegato che “bisogna ripristinare il materiale concesso a Kiev con i cinque decreti del precedente governo”. Ecco, quindi, che non si tratta più di una scelta “politica” e quindi opinabile, ma di una necessità. Anzi di una emergenza: in risposta ai commenti dei partiti all’opposizione, il ministro ha ricordato che “gli aiuti all’Ucraina sono stati votati anche da loro” quando erano al governo e che l’impegno di arrivare al 2 per cento del PIL in favore della Difesa “è un obiettivo confermato dall’allora presidente del Consiglio Conte”, nel 2018 e, poi, nel 2019. Anche durante il governo Draghi si sarebbe cercato di fare la stessa cosa: un resoconto stilato dalla Difesa parla dell’efficienza dei carri corazzati dell’Esercito “ridotta al 25-30 per cento” a causa dell’”obsolescenza” del materiale e della “cannibalizzazione” dei pezzi di ricambio. Per gli aerei da combattimento la situazione non è molto diversa: nonostante la discussa decisione di spendere una montagna di soldi per i discutibili F35, l’Aeronautica non disporrebbe di una sufficiente quantità di missili. Per questo, è stato deciso l’acquisto di altre armi (e dei relativi armamenti): “nuove” sofisticate batterie anti-missile. Situazione analoga per la Marina: anche qui le armi a disposizione sarebbero all’avanguardia, ma in caso di guerra si disporrebbe di munizioni per non più di una settimana. E ancora una volta, come ha ribadito il sottosegretario Perego, il problema delle scorte di armi e armamenti è “una questione strategica”.
Analoga la situazione in altri paesi europei. L’anno scorso il governo del socialdemocratico Schulz aveva annunciato lo stanziamento di cento miliardi di euro per “rinnovare” le strutture militari tedesche. E oltralpe, il presidente Macron ha dichiarato che “la Francia è entrata in un’economia di guerra, perciò sarà indispensabile ricostruire rapidamente ciò che serve alle nostre Forze Armate”.
A questo si aggiunge un altro aspetto. Per strano che possa sembrare, munizioni e armamenti sono come i farmaci o i prodotti alimentari che si comprano nei supermercati: hanno una data di scadenza. Dopo un certo lasso di tempo, bombe e missili “scadono”, diventano poco efficienti se non addirittura pericolosi da utilizzare. Questo, però, significa che periodicamente devono essere sostituiti. Inutile dire che tutto questo porta a produrre sempre più armi e armamenti.
Non sorprende se, in molti paesi sviluppati, il comparto legato alla produzione di armi e armamenti è rimasto attivo e florido anche nei momenti di crisi. Secondo i dati del database della Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel decennio dal 2010 al 2020, le 100 maggiori aziende produttrici di armi e armamenti avrebbero fatturato circa cinquemila miliardi di dollari. (6) Dal 2015 in poi, non c’è mai stato un calo nella corsa alla vendita e all’acquisto di armi, che sono via via aumentati. E, con loro, il fatturato delle aziende produttrici di strumenti di morte. E, ovviamente, il PIL dei paesi dove queste armi vengono prodotte.
C’è stato chi ha detto che, in realtà, questo varrebbe sia per il settore delle armi militari che per altre armi quelle “sportive”. Per capire he la verità è ben diversa basta leggere i dati della ricerca commissionata da ANPAM, l’associazione nazionale dei produttori di armi e munizioni all’Università di Urbino, in Italia la produzione di armi e munizioni “comuni”, ovvero escluse quelle militari, genererebbe un fatturato di circa 600 milioni di euro. Cifre ben lontane dal settore militare: qui il valore delle esportazioni nel 2020 è stato di 4,647 miliardi di euro.
Possibile è così facile vendere armi e armamenti a paesi in guerra?
A regolare la vendita di armi e armamenti sono diverse norme di diritto internazionale. Queste impongono alcuni paletti: “chi” può vendere, “cosa” si può vendere e a “chi”.
Purtroppo, molto spesso, queste norme vengono aggirate e i paesi maggiori produttori ed esportatori di armi vendono quello che vogliono a chi vogliono. Basta che paghi.
Esemplare il caso delle motovedette o degli elicotteri venduti all’India dall’Italia. Qualche anno fa scoppiò una polemica che finì in Parlamento (in quel periodo era un tema caldo per la questione dei marò). La risposta fu che entrambi non rientrerebbero nel novero delle “armi” non essendo “armati”e destinati solo ad azioni di addestramento o sorveglianza. Dimenticando che questi mezzi potrebbero essere facilmente armati (come confermerebbero le foto delle motovedette vendute all’India apparse su alcuni giornali dotate di armi acquistate da altri paesi).
In molti paesi sviluppati, quando si parla di armi e armamenti, il conflitto tra economia e etica è sempre stato a favore della prima. Dimenticando che quando qualcuno spara c’è sempre qualcuno che gli ha permesso di farlo, che ha costruito quell’arma. Che gli ha permesso di disporne e di utilizzarla. Vale per tutte le guerre. Dalle bombe in Yemen a quelle in Ucraina. Dalla Siria a Israele. Fino a tutte quelle guerre “minori” che ogni giorno causano centinaia, migliaia di morti dei quali non parla nessuno.
Lo scorso anno, il Parlamento italiano ha approvato di aumentare la voce di spesa in armi e armamenti fino al 2 per cento del PIL. Una decisione giustificata dall’allora Presidente del Consiglio Conte che definì “l’Ordine del giorno proposto dalla Lega … un semplice adeguamento ad un impegno già preso”. Lo stesso Conte dovette ammettere che si trattava di una scelta priva di ogni raziocinio: “Diciamo che in un momento in cui c’è un caro bollette ed un caro benzina non avrei tutto questo entusiasmo nel ribadire quello che è stato un impegno preso già da tempo”. La decisione venne giustificata dicendo che grazie allo stanziamento di questi fondi, le Forze armate avrebbero potuto rispondere a missioni decisive: la difesa dello Stato e dei suoi interessi vitali, la difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei, le missioni internazionali. Si disse che, grazie a questo impegno di spesa, il paese avrebbe potuto “contare su uno strumento militare capace di difenderlo da tutte le forme di rischi”. Ora, dopo pochi mesi, si scopre che non è così. Che sono necessarie nuove armi, e sempre più soldi per rimpinguare gli arsenali di armi e armamenti sempre più tecnologici. Sempre più efficienti. Sempre più mortali.
Qui non si sta facendo pacifismo spicciolo. Ma esiste una grande differenza tra voler difendere il proprio paese e spendere miliardi di euro in armi e armamenti per un mero ritorno economico. È per questo, forse, che da qualche tempo alcuni politici cercano di giustificare la guerra: per consentire, anzi, per favorire la vendita di miliardi di dollari in armi e armamenti. È per questo che, mentre da un lato si parla (e si scrivono leggi e accordi internazionali) di “pace”, dall’altro si continuano a produrre sempre più armi. Armi per le quali i governi spendono migliaia di miliardi di dollari ogni anno. Armi che servono per combattere guerre che, secondo loro, dovrebbero portare la pace.
Quello che nessun politico dice è che, per vivere in pace, basterebbe molto meno. Se, come dicono loro, la pace serve per aiutare le popolazioni, per eliminare la fame, allora dovrebbero spiegare come mai non utilizzano questi soldi per aiutare chi muore di fame. Anzi secondo alcune stime, i conflitti sono la prima causa della fame nel mondo. “Se i governi rinunciassero alle spese militari per sole 26 ore, avremmo 5,5 miliardi di dollari a disposizione per salvare 34 milioni di persone dalla fame nei prossimi mesi in Paesi piegati da guerra, pandemia e cambiamenti climatici”, è l’appello lanciato da Oxfam e oltre 250 associazioni. (7)
Nel 2015, tutti i rappresentati dei paesi facenti parte delle Nazioni Unite approvarono gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030. Il primo di questi 17 Obiettivi è “Sconfiggere la povertà una volta per tutte”. Il secondo recita “Eliminare la fame nel mondo”. Oggi, nel mondo, sono miliardi i poveri e il loro numero continua ad aumentare. Avere alzato la soglia di povertà per ridurre il numero di persone in povertà estrema non ha risolto il problema: è stato un trucchetto statistico che è riuscito a nascondere i numeri reali solo agli occhi di chi non legge fino in fondo i dati reali. Quanto alla fame continua ad essere una delle piaghe aperte della società globale: nel mondo una persona su otto soffre la fame: 821 milioni di bambini, donne e uomini. E questo numero sta aumentando. Fame e povertà sono due fenomeni che viaggiano fianco a fianco: il costo più elevato del cibo spesso causa uno scarsa nutrizione.
Eppure entrambi questi fenomeni sarebbero non solo controllabili, ma eliminabili. A confermalo è Byanyima, direttrice di Oxfam International: “La fame è un prodotto dell’azione umana che alimenta povertà e disuguaglianze, guerre, malgoverno, sprechi e cambiamento climatico. Per sconfiggere definitivamente questo inaccettabile stato di cose, ci vuole lo stesso impegno politico che stiamo mettendo nel lasciare intere comunità morire di fame”. Non è la prima volta che vengono confrontate le spese stanziate per le guerre e, dall’altro lato, il costo che avrebbe eliminare radicalmente fame e povertà nel mondo. Secondo il rapporto presentato al Global Forum di Roma ad ottobre dello scorso anno basterebbero “risorse aggiuntive fino a 265 miliardi di dollari per porre fine alla povertà e alla fame entro il 2030”. 265 miliardi di dollari. Una briciola degli oltre duemila miliardi di dollari spesi ogni anno in armi e armamenti. Una briciola anche pensando che storicamente, secondo lo studio “United States Budgetary Costs of the Post-9/11 Wars Through FY2019: $5.9 Trillion Spent and Obligated”, solo gli USA, dal 2011 ad oggi, hanno speso ben 5.993 miliardi di dollari in guerre, missioni di pace e affini.
Non è vero che oggi non è possibile porre fine una volta per tutte a fame e povertà cronica: i governi dispongono di risorse in abbondanza per farlo. Basterebbe circa lo 0,3 per cento del PIL globale, stimato dalla Banca mondiale in oltre 80 mila miliardi di dollari a fine 2017. Invece, si preferisce destinare una somma molto maggiore (il 2 per cento per i paesi NATO) per comprare armi e armamenti per combattere guerre che non serviranno a portare la pace e che produrranno sempre più morti, fame e povertà.
“La Storia vi giudicherà”è l’avvertimento contenuto nella lettera aperta pubblicata dalle 250 associazioni con Oxfam, “Vi esortiamo a investire nella riduzione di povertà e fame, per dare alle persone gli strumenti di cui hanno bisogno per costruirsi un futuro più resiliente, per adattarsi in modo sostenibile ai cambiamenti climatici e proteggersi dagli shock del COVID-19. Questo contribuirà a prevenire futuri conflitti e sfollamenti. Questo eviterà la fame e le carestie future. Non c’è posto per la carestia e la fame nel 21esimo secolo. La storia ci giudicherà tutti in base alle azioni che intraprenderemo oggi”.
Purtroppo, la storia ci insegna che a chi produce armi e armamenti e a chi fa di tutto per combattere le guerre, del giudizio della storia non è mai importato molto.

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.
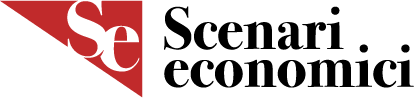
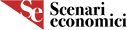







You must be logged in to post a comment Login