EconomiaGermania
“Tschüss, Deutschland”: L’industria tedesca fa le valigie. Ecco i 5 motivi della fuga
Un sondaggio shock rivela la fuga dell’industria tedesca: 7 aziende su 10 bloccano gli investimenti in patria. Costi energetici fuori controllo, burocrazia e la delusione per il nuovo governo stanno distruggendo il “Modello Germania”.

Tschüss, Deutschland, Addio Germania. La locomotiva d’Europa non solo perde colpi: sta attivamente disinvestendo da sé stessa. Quello che fino a poco tempo fa era un timore sussurrato nei corridoi, ora è un dato di fatto confermato da un sondaggio che dovrebbe far suonare più di un campanello d’allarme a Berlino.
Uno studio della società di consulenza Simon Kucher, ripresa da Handelsblatt, che ha intervistato 240 manager di alto livello in Europa e negli Stati Uniti tra luglio e settembre 2025, dipinge un quadro desolante.
Il 70% delle imprese industriali tedesche intervistate sta di fatto bloccando gli investimenti in patria. Nello specifico:
- 31% sta attivamente trasferendo o espandendo la produzione in altri continenti.
- 42% sta investendo in altri paesi europei (invece che in Germania) o ha rinviato a tempo indeterminato gli investimenti sul suolo tedesco.
Solo il 27% continua a investire nel proprio Paese, come se nulla fosse.
La rilevazione si è concentrata sui settori energy intensive – chimica di base, acciaio, vetro e cemento – ovvero il cuore pulsante dell’industria pesante tedesca. Non si tratta più di “giochi mentali” o strategie di negoziazione: “Ora osserviamo concretamente come mai prima d’ora che le aziende scelgono di investire in Cina, India o Stati Uniti”, conferma l’avvocato Yvonne Hanke, che assiste queste imprese.
Christof Günther, amministratore delegato di Infraleuna (un operatore di siti chimici), è ancora più netto: “Attualmente stiamo perdendo ogni settimana, in modo massiccio e irrecuperabile, valore aggiunto industriale in Germania”.
Ma perché la Germania, un tempo modello industriale invidiato, è diventata improvvisamente un luogo da cui fuggire? L’analisi dell’Handelsblatt, basata su colloqui con i rappresentanti del settore, identifica cinque problemi principali.
1. Il sogno (infranto) dell’idrogeno contro il prezzo crescente della CO₂
La grande transizione verde si sta rivelando un incubo finanziario. I piani, avviati dal precedente governo (Habeck) e proseguiti dall’attuale, per convertire l’industria pesante da carbone e gas all’idrogeno, si scontrano con la realtà: l’idrogeno è e rimarrà costoso per molto tempo.
Arcelor-Mittal, colosso dell’acciaio, ha già bloccato a giugno la costruzione di impianti di produzione “climaticamente neutri” (DRI) a Brema ed Eisenhüttenstadt. Il motivo? “La riduzione con idrogeno non è un’opzione competitiva”. L’azienda costruirà il suo primo impianto DRI “verde” in Francia, dove l’energia costa meno.
Mentre le speranze sull’idrogeno svaniscono, i costi per l’inquinamento aumentano. Le aziende devono acquistare certificati di emissione per ogni tonnellata di $CO 2$. L’UE sta eliminando le quote gratuite, aumentando la pressione sui prezzi. “La tassa sulla $CO_2$ per l’Europa deve sparire”, ha tuonato Christian Kullmann, capo del gruppo chimico Evonik.
2. Incertezza politica: finita la “luna di miele” col nuovo governo
L’euforia per il cambio di governo a Berlino (avvenuto a maggio) è già evaporata. Un sondaggio del BVMW (l’associazione delle PMI) è impietoso: l’80% degli imprenditori non crede che l’attuale esecutivo realizzerà “riforme significative”.
Le misure finora adottate, come il sussidio da 6,5 miliardi di euro per i costi di rete elettrica, sono viste come una goccia nel mare. Per il sito chimico di Leuna, ad esempio, questo “aiuto” copre appena il 2-3% dei costi totali dell’elettricità.
“È già cinque minuti dopo mezzanotte per la Germania come piazza industriale”, avverte un portavoce di Lanxess. I problemi sono sempre gli stessi, e irrisolti: costi energetici estremi, burocrazia soffocante e carenza di manodopera qualificata.
3. Le nuove regole doganali e le importazioni “sleali”
Un effetto collaterale delle guerre commerciali iniziate da Trump. Gli alti dazi statunitensi spingono la Cina a dirottare le sue merci (spesso a basso costo) verso l’Europa. Contemporaneamente, i produttori americani (ad esempio nella chimica di base) possono esportare nell’UE senza dazi.
Il risultato? “Una marea continua di importazioni sleali provenienti da Paesi terzi”, lamenta Arcelor-Mittal. Questo costringe le aziende europee, come il produttore di vetri speciali Schott, ad adottare una strategia “local for local”: produrre localmente per i mercati locali, al fine di ridurre la dipendenza e reagire alle diverse condizioni nazionali.
4. La congiuntura debole che fa crollare la domanda
L’economia tedesca semplicemente non riparte. La Bundesbank prevede, nel migliore dei casi, una stagnazione per il terzo trimestre. L’industria lo sente pesantemente: gli impianti chimici viaggiano a un tasso di utilizzo del 71%, quando la soglia di redditività è stimata all’82%.
Questa debolezza della domanda, unita ai costi altissimi, crea una pressione che costringe le aziende a prendere decisioni drastiche ora.
Comunque, in generale, si produce dove c’è domanda. La Germanbia, anzi la UE, punisce la domanda, quindi la produzione va altrove.
5. Da crisi congiunturale a declino strutturale
I dati ufficiali non mentono più. La produzione nei settori ad alta intensità energetica è crollata del 15% rispetto ai livelli pre-crisi (fine 2019).
Fino al 2023, un indicatore più ampio – il “valore aggiunto” industriale (che include anche i servizi come la manutenzione) – era rimasto stabile. Ora crolla anche quello: -3,6% rispetto al pre-crisi. Non è più un rallentamento ciclico, è un problema strutturale.
La BASF è brutale nella sua onestà: “Entro il 2030, la regione Asia-Pacifico rappresenterà circa il 70% del mercato chimico globale”. L’azienda sta quindi costruendo un nuovo gigantesco sito a Zhanjiang, in Cina, perché è lì che cresce il mercato. Non a Leuna.
Una debole speranza arriva dal capo di Deutsche Bank, Christian Sewing, secondo cui la tendenza “non è ancora irreversibile”, a patto che il governo agisca adesso con riforme strutturali. Ma, come conclude amaramente Günther di Infraleuna: “Si può resistere ai brutti momenti per un po’. Ma se poi non ti viene data alcuna prospettiva, si prende la decisione di chiudere”. E, soprattutto, né in Germania né nell’Europa socialista si vede un’inversione di tendenza. Quindi, Tschüss, Deutschland.
Domande e Risposte (FAQ)
1. Perché le aziende tedesche fuggono proprio ora?
La fuga è causata da una “tempesta perfetta”. I costi energetici, già alti, sono diventati insostenibili e i piani di transizione (come l’idrogeno) si stanno rivelando troppo costosi o irrealistici. A questo si aggiungono una burocrazia che non è migliorata col nuovo governo, una domanda interna ed europea debole e una crescente concorrenza “sleale” da parte di importazioni a basso costo (ad esempio cinesi) e americane (avvantaggiate da dazi e costi energetici inferiori). La debolezza congiunturale sta semplicemente forzando decisioni strutturali che erano già nell’aria.
2. Il nuovo governo tedesco sta facendo peggio del precedente (Scholz/Habeck)?
L’articolo evidenzia una forte disillusione. C’era molta attesa dopo la fine della coalizione “semaforo” (Ampel), ma secondo gli industriali ai piani non sono seguiti i fatti. L’80% delle PMI non si aspetta riforme. Gli aiuti finora stanziati (come quelli sui costi di rete) sono giudicati insufficienti. Se il governo precedente è criticato per aver impostato una transizione verde costosa (idrogeno), quello attuale è criticato per non fornire soluzioni praticabili o un sollievo economico reale, lasciando le imprese in un limbo.
3. Quali settori sono più a rischio e dove stanno andando?
I settori più a rischio sono quelli energy intensive, ovvero che consumano enormi quantità di energia: chimica di base, acciaio, vetro e cemento. Questi sono il cuore dell’industria pesante tedesca. Le destinazioni sono due: per la produzione ad alto valore aggiunto si cercano Paesi con costi energetici più bassi ma stabili (come la Francia, citata per l’impianto Arcelor-Mittal, o gli USA, grazie all’Inflation Reduction Act); per la produzione destinata ai mercati in crescita, si va direttamente lì, come fa BASF costruendo in Cina, che rappresenterà il 70% del mercato chimico.
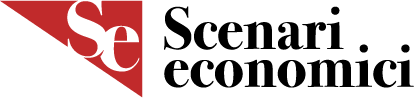
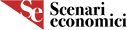







You must be logged in to post a comment Login