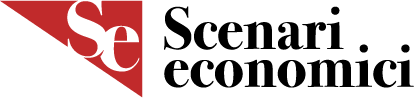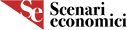Attualità
NEOLIBERISMO, MALE D’EUROPA (di Marcello Concialdi e Giorgio Corona)
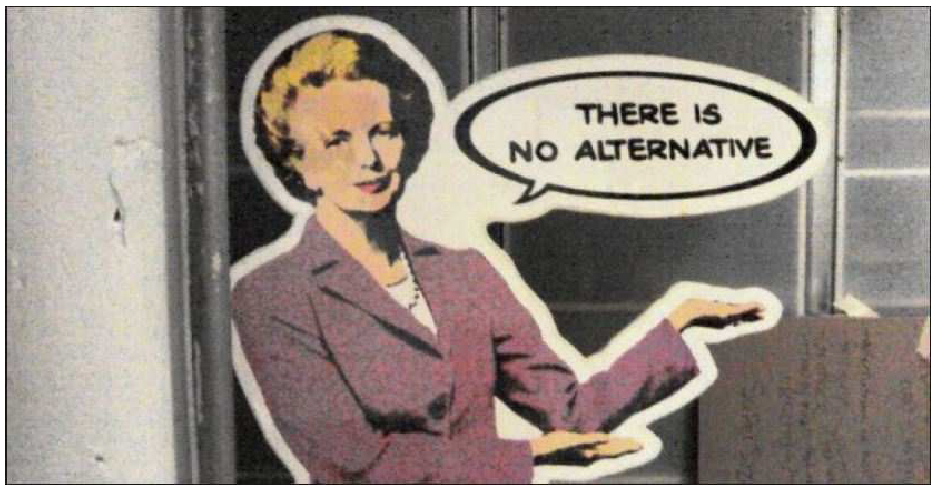
La nascita della civiltà occidentale è situabile nella Grecia antica e coincide
con l’avvento del pensiero filosofico. Si tratta di un evento che ha generato la
corrente maniera di pensare, poiché è in esso che si sono affinati i concetti e le
categorie che tutt’ora stanno alla base della nostra morale e della nostra cultura.
Uno degli eventi fondamentali della nascita del pensiero filosofico è stata la nascita
della politica democratica nelle polis greche. Secondo Louis Gernet – grecista del
Novecento e studioso della giurisprudenza arcaica – e Jean-Pierre Vernant – storico
francese – è il passaggio dall’epoca del prediritto a quella del diritto giuridico a porre
le basi per l’avvento della metodologia dialettica, che è alla base delle dinamiche
scientifiche e che dovrebbe armonizzare, come in quel momento aurorale, i conflitti
politici. I due grandi studiosi francesi ritengono che è attraverso la riforma di Solone
che si sono poste le basi per lo sviluppo del confronto democratico e per la nascita
del pensiero occidentale. In democrazia – l’aurorale eunomia di Solone – il conflitto
si traduce in conflitto verbale: nascita della dialettica e della filosofia.
La riforma solonica è del VI secolo a.C. e, al contrario di quella
precedente di Dracone, ha il fine di portare a termine il conflitto
sociale in atto tra un popolo tormentato dai propri debiti e
un’aristocrazia che pretendeva di mantenere i propri privilegi,
dedicandosi esclusivamente alla coltivazione del lusso importato
da Oriente. I contadini erano gravati da debiti contratti con
l’aristocrazia e avevano messo a garanzia non solo i propri beni,
ma anche la propria libertà, per cui un debitore insolvente, come da prassi
nell’antichità, diveniva schiavo del creditore.
Questo aggravarsi del debito condusse a una gravissima tensione fra
l’aristocrazia e il demos. Attraverso la riforma solonica i debiti furono cancellati e
vennero proibiti i prestiti con la persona a garanzia e furono liberati gli schiavi. La
riforma di Solone fu anche una riforma censocratica che ebbe come risultato
diminuzione del conflitto e una maggiore armonizzazione maggiore delle classi
sociali, grazie all’estensione della vita politica a classi sociali che ne erano escluse. È
l’estensione della vita politica al demos che è la base dell’attuale concetto di
democrazia.
La riforma di Solone per Michel Foucault, come si evince dal suo corso al
Collège de France del 1971 Lezioni sulla volontà di sapere, è anche una riforma
legata al ruolo della moneta, che diventa uno strumento per regolare le
inuguaglianze, cause di conflitto.
La moneta è prima di tutto uno strumento di regolazione tra i diversi elementi che
costituiscono la città: attraverso la distribuzione di moneta sotto forma di regali o di
doni, si evita che i poveri divengano troppo poveri; attraverso l’imposta prelevata sui
ricchi si evita che i ricchi siano troppo ricchi. La moneta è metron – uno strumento, una
misura – ma nel senso che essa impedisce l’eccesso.
È evidente che la riforma solonica introduce il concetto di medietà che sarà colonna
portante della politica democratica, ma soprattutto che segnerà la filosofia in
quanto produzione di una critica al costume dell’egoismo e del lusso a scapito
dell’altro. L’essere morale è colui il quale è distante dall’accumulo dei beni e delle
ricchezze, è l’uomo che vive senza tracotanza, è l’uomo temperante, è giusto. La
filosofia greca antica, tramite Socrate, Platone, Aristotele e l’ellenismo, produce il
concetto di uomo morale secondo questi margini, che saranno i medesimi del
Cristianesimo: dismissione dei beni eccessivi, presa di distanza dall’egoismo, cura
dell’altro.
Questa idea di uomo è un’ideale ed è fondamentale proprio in quanto ideale,
ovvero in quanto modello di contrasto della realtà, nella quale l’uomo segue
tendenze egoistiche e individualistiche – specie in un sistema culturalmente non
gerarchico come poteva essere quello egizio o indiano. La filosofia ha sempre
proposto questo modello sulla base del quale nasce l’ideale di giustizia e di Stato:
ammissione dei limiti dell’uomo e regolazione delle sue storture, a vantaggio di tutti.
L’epoca nella quale viviamo invece è accondiscendente con un modello
contrario a questo. L’epoca è quella del pensiero unico dominante del neoliberismo,
che ha avuto come conseguenza quella che Michel Houellebecq chiama estensione
del dominio della lotta nel suo romanzo Le particelle elementari.
Il liberalismo economico è l’estensione del dominio della lotta, la sua estensione a tutte
le età della vita e a tutte le classi della società.
Il conflitto è costante ed è esteso alla società intera, che ne esce completamente
disgregata e impoverita, come il trentennio di neoliberismo sta mostrando, senza sé
e senza ma: aumento delle disuguaglianze e aumento dei conflitti diffusi in ogni
parte del globo, con l’aumento di quello che tutta la storia della cultura occidentale
scientifica e umanistica ha avuto finora come obiettivo: la riduzione della sofferenza
umana. La sofferenza umana aumenta, perché il modello neoliberista propone
l’idea che i mercati si autoregolino, che non necessitino dunque dello Stato in
quanto controllore dell’economia – ma solo in quanto legislatore delle direttive
economiche – e che il principio di azione sui mercati debba essere l’egoismo.
Il modello neoliberista della Mps – che è, ad esempio, quello alla base delle
politiche criminali della Thatcher – affonda le sue radici nella riflessione di Adam
Smith (1723-1790).
Ma Smith, da dove deriva i principi della sua descrizione economica de La
ricchezza delle nazioni?
Per il Louis Dumont di Homo æqualis 1. Genesi e trionfo dell’ideologia economica è
con François Quesnay (1694-1774) che per la prima volta l’economico sottomette
lo Stato: lo stato deve astenersi dall’intervenire nelle transazioni economiche.
Questo perché per Quesnay le leggi fisiche della natura regolano quelle morali.
L’economia ha un funzionamento paragonabile a quello delle leggi fisiche, dunque
subordina l’ambito morale e politico – per natura, appunto. Questo tema è mutuato
da Smith, che mutua anche quello di Mandeville della Favola delle api. È noto il testo
nel quale Mandeville afferma che sono i vizi degli uomini e l’egoismo nei confronti
dei beni di lusso a essere il motore economico che produce ricchezza diffusa: si
tratta del sofisma della creazione del lavoro secondo il quale la domanda crea
l’offerta e la domanda di lavoro crea lavoratori. In Mandeville la frugalità è un freno
economico.
I due asserti che condizionano la visione economica
di Smith e quindi quella del neoliberismo –
economia sopra lo stato ed egoismo come motore
dell’economia – sono ciò che è più lontano dalla
nascita della civiltà occidentale per come si è
delineata storicamente e culturalmente. Se essa
nasce nel dominio della politica e della morale, è
con il neoliberismo imperante che per la prima volta
l’uomo agisce con la convinzione ideologica che
tutte le regole morali che regolano i rapporti sociali e giuridici valgano in tutti gli
ambiti, tranne in quelli economici. I rapporti morali secondo il modello della
temperanza non devono nemmeno valere in ambito politico, poiché questo ambito
è subordinato all’economico e si svuota della sua funzione: regolare le
disuguaglianze per il bene comune.
In questo senso il neoliberismo è la distruzione delle radici dell’Occidente e
della democrazia, poiché affonda i denti e sbrana proprio ciò che più è radicato nella
produzione culturale, umanistica, scientifica e religiosa dell’Occidente: l’ideale di
uomo morale è l’uomo che aborre l’egoismo.
MARCELLO CONCIALDI
GIORGIO CORONA