Conti pubbliciEconomiaFrancia
La Tassa Zucman: buone intenzioni e la dura lezione norvegese sull’esilio fiscale
Tassa Zucman sui super-ricchi: l’idea si scontra con la realtà. Uno studio shock dalla Norvegia rivela che un lieve aumento delle tasse patrimoniali ha decuplicato la fuga di capitali, mettendo in discussione i 20 miliardi di gettito attesi in Francia e mostrando danni all’economia reale.

Prima di addentrarci nell’analisi, definiamo il “giocattolo” al centro del dibattito francese: cos’è la “Tassa Zucman”?
Come da Lei indicato, si tratta di una proposta dell’economista (molto in voga a sinistra) Gabriel Zucman. L’idea è semplice: un’imposta del 2% sui patrimoni (finanziari, immobiliari e, punto cruciale, anche i beni professionali) che superano i 100 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è raccogliere circa 20 miliardi di euro all’anno da destinare a vari scopi nobili (transizione ecologica, difesa, debito).
In Francia, la proposta è stata (per ora) respinta per la legge di bilancio 2026, ma il tema resta caldissimo.
L’inferno fiscale è lastricato di buone intenzioni
La tassa Zucman, che tanto ha animato i dibattiti politici, sarebbe un perfetto esempio di come le buone intenzioni possano scontrarsi con la dura realtà. L’idea di fondo è garantire che i “super-ricchi” contribuiscano di più, riducendo la concentrazione della ricchezza e rafforzando la (presunta) coesione sociale.
E la paura dell’esilio fiscale? I difensori della tassa, Zucman in testa, la liquidano come un rischio “modesto”. Peccato che uno studio empirico, basato su dati reali e pubblicato il 9 novembre dalla ricercatrice Christine Blandhol (Università di Princeton), racconti una storia molto, molto diversa.
Il “piccolo” esperimento norvegese
Lo studio (“Curbing tax flight? Aggregate effects of taxing entrepreneur migration“) analizza un caso reale che assomiglia molto alla proposta francese: la Norvegia.
Nel 2022, il governo norvegese ha aumentato la sua imposta sulla fortuna (anch’essa includente i beni professionali) da 0,85% a 1,1% per i patrimoni superiori a 1,7 milioni di euro. Un aumento di “soli” 0,25 punti percentuali.
Cosa è successo? Vediamo i dati:
- Prima della riforma: Il tasso annuo di esilio fiscale tra i più ricchi (quelli con oltre 8,5 milioni di euro) era dello 0,2%.
- Dopo la riforma: Il tasso annuo di esilio fiscale è balzato al 2%.
In sintesi: per un ritocco fiscale minimo, la fuga dei contribuenti più ricchi è decuplicata. Non raddoppiata. Decuplicata.
L’elasticità maledetta (per chi impone le tasse)
L’autrice dello studio stima “l’elasticità dell’esilio fiscale” per questa fascia di popolazione a -10,16.
Cosa significa in parole povere? Significa che per ogni punto percentuale di aumento della tassazione sul patrimonio, il 10% (in punti percentuali) di questi contribuenti fa le valigie e se ne va. È una reazione estremamente sensibile, tale da far saltare tutti i calcoli a monti sugli introiti.
Ad approfittarne , in senso opposto, sono i paesi che si rifiutano di applicare le tasse patrimoniali , che ricevono un reddito aggiuntivo imprevisto.
Cosa accadrebbe in Francia se fosse applicata la tassa?
Applichiamo questa elasticità alla “Tassa Zucman” del 2%. L‘economista Antoine Levy (Berkeley) fa il calcolo e il risultato è impietoso: “si tradurrebbe in un esilio annuale di circa il 20% dello stock” dei ricchi, che se ne andrebbe.
In pratica, il gettito fiscale atteso sparirebbe quasi istantaneamente nel giro di 4-5 anni.
Ricordiamo che questa tassa riguarda circa 1.800 famiglie, ma la metà del suo rendimento teorico (circa 10 miliardi) è assicurata da meno di dieci famiglie. Lo stesso Zucman l’ha definita la “Tassa Bernard Arnault”. Basta che quelle dieci famiglie prendano un aereo per la Svizzera o l’Italia, e il gettito è già dimezzato. Una cinquantina di persone cancellano la tassa.
La ricaduta per la sparizione dei consumi sarebbe forte, a fronte di cosa? Di nessun gettito fiscale. Neanche il Monti dei tempi migliori potrebbe studiare una pessima tassa simile.
E gli studi che dicevano il contrario?
I sostenitori della tassa amano citare uno studio del CAE (Consiglio di Analisi Economica francese) che parlava di un effetto “relativamente modesto”. Ma, come sottolinea Lévy, c’è una differenza fondamentale:
- I “piccoli ricchi” vs i “super-ricchi”: Lo studio CAE analizzava il “top 1%”, ma l’esperienza norvegese dimostra che i patrimoni molto alti (oltre 10 milioni) sono molto più mobili dei “piccoli ricchi”.
- I beni professionali: Il CAE non si è pronunciato su una tassazione che includesse i beni professionali, che sono il vero patrimonio degli imprenditori e il cuore della tassa Zucman.
Il danno oltre la beffa: l’impatto sull’economia reale
Il problema non è solo il mancato gettito. È il valore che se ne va. Lo studio norvegese rileva un altro dato inquietante: “più del 40% dei contribuenti che si esiliano fiscalmente sono proprietari attivi di imprese”.
E quando questi imprenditori se ne vanno? Le loro società (rimaste in Norvegia) mostrano un calo di fatturato del 12,6%.
Questo significa meno investimenti, meno occupazione e un indebolimento generale del tessuto produttivo. In sintesi: la tassa Zucman, proposta per raccogliere 20 miliardi (stima forse già ottimistica, il Nobel Aghion parlava di 5 miliardi il primo anno), rischia non solo di non raccogliere nulla dopo pochi anni, ma di danneggiare attivamente l’economia reale.
Domande e risposte
Cosa differenzia la Tassa Zucman da altre imposte patrimoniali? La Tassa Zucman si distingue per due motivi. Primo, l’aliquota è molto alta (2%) su una soglia elevata (100 milioni di euro). Secondo, e più importante, include esplicitamente i “beni professionali” (le aziende, le partecipazioni) nel calcolo, cosa che molte patrimoniali, come la vecchia ISF francese, tendevano a escludere per non colpire gli imprenditori attivi. È questo che la rende particolarmente invisa al mondo imprenditoriale e, come visto, pericolosa.
Si può davvero paragonare la Norvegia alla Francia? Sebbene i due paesi abbiano sistemi fiscali diversi, l’esperimento norvegese è molto rilevante. È uno dei pochi casi reali in cui si è tassato il patrimonio (inclusi i beni professionali) di fasce molto ricche. Lo studio misura la “reattività” (elasticità) di questi contribuenti all’aumento delle tasse. Dimostra che, contrariamente a quanto teorizzato da alcuni, i super-ricchi non sono affatto “prigionieri” del loro paese, ma estremamente mobili. È probabile che i super-ricchi francesi non siano meno mobili di quelli norvegesi.
Quali sono i rischi oltre alla fuga dei capitali? Il rischio principale, evidenziato dallo studio norvegese, è il danno all’economia reale. Oltre il 40% di coloro che sono fuggiti dalla Norvegia erano imprenditori attivi. Le loro aziende, rimaste in patria, hanno subito un calo di fatturato del 12,6%. Questo significa meno investimenti, meno occupazione e un indebolimento del tessuto produttivo nazionale. La tassa, pensata per raccogliere fondi, finisce per distruggere la base imponibile e il valore economico futuro.
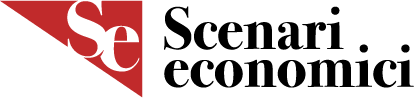
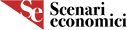







You must be logged in to post a comment Login