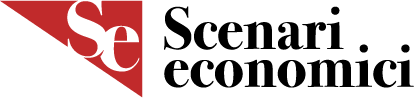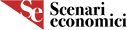Politica
IL FIGLIO DI GHEDDAFI, CONDANNATO A MORTE
Il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam, è stato condannato a morte, per fortuna in contumacia: nel senso che il gruppo libico che lo tiene in galera da circa quattro anni non è lo stesso che l’ha condannato. Dunque può anche darsi che quella condanna sia servita solo a far scrivere qualche distratto titolo di giornale. Ma va lo stesso spiegato perché è stata usata l’espressione “per fortuna”.
La condanna a morte del nemico è pratica antichissima e dunque non ci si stupisce. Malauguratamente l’epoca contemporanea da un lato è feroce come tutte le altre, dall’altro vuole anche “avere ragione”: dunque non si limita ad uccidere, vuole anche condannare. E con questo crea un problema. Infatti è un errore pretendere di applicare alla politica e alla guerra le regole previste per il tempo di pace, fra privati.
Prendiamo un esempio classico. Una “diversione”, in guerra, è un’azione militare tendente ad ingannare il nemico. Il generale ordina ad un reparto di attaccare il nemico nel punto A, in modo che la reazione si concentri su quel punto (massacrando totalmente il reparto) mentre il grosso dell’esercito attacca il punto B, che il nemico ha lasciato relativamente sguarnito. Se l’operazione riesce, il generale è considerato un bravo tattico e probabilmente gli saranno affidate altre iniziative, nella speranza che abbia lo stesso successo. Ma come stanno le cose dal punto di vista penale?
Secondo il codice, si può uccidere per difendersi da un pericolo più o meno mortale, e si può anche uccidere per salvare un’altra persona, ma il pericolo deve essere attuale e non altrimenti evitabile. Il caso del generale è del tutto diverso. Personalmente non era in pericolo e non era in pericolo nemmeno il suo esercito, quanto meno sul momento. Dunque l’alto ufficiale ha ordinato ad un reparto di andare incontro a morte pressoché sicura, e per il diritto penale questo è omicidio volontario. Va dunque condannato?
Nient’affatto. Va soltanto riconosciuto che la guerra non ha le stesse regole della vita normale. E non le ha neppure la politica. Questa trasgredisce correntemente i dettami della morale, della correttezza, della lealtà e persino dell’onore. La sua stella polare – e stiamo parlando dei migliori politici – è l’interesse dello Stato. Dinanzi ad esso ogni altra considerazione deve cedere il passo. Proprio per questo, nel caso di una sommossa, la decisione di tollerarla, incoraggiarla o reprimerla nel sangue non è una decisione giuridica, è una decisione politica. Chi decide deve rispondere soltanto a questa domanda: quale comportamento è più conveniente per lo Stato?
E in seguito, se la sommossa si trasforma in rivoluzione vincente, chi ne aveva ordinato la repressione sanguinosa (è il caso di Saif al-Islam) non va condannato. I vincitori infatti non hanno il diritto morale di ergersi a giudici semplicemente perché, al posto del precedente governo, si sarebbero comportati nello stesso modo. La storia russa ci ha raccontato cento volte la nequizia dello zar che ordinò di sparare sui rivoltosi inermi, ma il regime che seguì – quello di Lenin e Stalin – fu forse più tollerante e meno sanguinario?
Si può uccidere il nemico vinto, ma perché avere la pretesa di farlo in nome della legge e della giustizia? L’unico atto per il quale è concepibile che intervenga il codice penale è quello non giustificato né dal punto di vista politico né da quello militare. Perché in questo caso, il soggetto agisce in quanto privato cittadino. Saddam Hussein andava condannato a morte parecchie volte, per le cose che ha fatto, ma non per la ragione per la quale è stato impiccato. La repressione col gas, uccidendo migliaia di persone, fu un atto politico: eccessivo, crudele, inumano, ma pur sempre politico. Né si può dire ai governi degli Stati sovrani in che modo devono governare.
Una inevitabile nota, in questo campo, riguarda il processo di Norimberga. Una ferita che non si rimarginerà mai. Qui il giudizio è complesso e per così dire sfrangiato, a causa delle molte perplessità da esso sollevato. Comunque fra le imputazioni ve n’è una ridicola e antigiuridica: l’inedito “reato” d’avere scatenato una guerra d’aggressione. A parte il fatto che è difficile distinguere una guerra d’aggressione da una guerra difensiva (quella “Dei Sei Giorni”, in cui Israele sferrò il primo colpo, fu forse una guerra d’aggressione?) a parte il fatto che bisognerebbe condannare come criminali personaggi del calibro di Alessandro Magno o Giulio Cesare, non si può condannare nessuno per un reato che non era previsto come tale al momento della commissione.
Viceversa non si può definire “azione di guerra” lo sterminio degli ebrei: questo costituì esclusivamente il più grande crimine doloso della storia, come dimensioni. Le stesse morti per fame (provocate da Mao Tse Tung) potrebbero ancora essere giudicate in grande misura “reati colposi”, ma per la Shoah non esistono esimenti. E tuttavia, anche qui, chi fu colpevole? Hitler, certamente, ma era morto. Anche Himmler, probabilmente. Ma chi aveva obbedito ai loro ordini? Brutto problema.
Per tutti questi motivi si guarda agli eventi libici con una certa mestizia. Non perché il figlio di quel dittatore sia simpatico, ma perché si osserva un ulteriore esempio della pretesa contemporanea di fare ciò che si ha voglia di fare, con in più la pretesa che corrisponda alla legge e alla giustizia. Questo ameremmo ci fosse risparmiato.
Gianni Pardo, pardonuovo@myblog.it
30 luglio 2015