Attualità
ANDY WARHOL RITORNA A BOLOGNA, CON HARING E BASQUIAT – PARTE PRIMA (di Marco Minossi)

Per la prima volta proponiamo il commento ad una mostra non dopo averla visitata, ma prima di farlo (dopo di che, ne riparleremo).
Dopo le recenti Bologna, Monza, Milano e Padova, l’Italia prosegue nella sua reattività perenne, mai doma, alla Pop Art americana, e a tre delle sue espressioni più significative: la produzione di Andy Warhol, di Keith Haring e di Jean Michel Basquiat. Nel frattempo, Roy Lichtenstein è a Parma per conto suo, a Palazzo Tarasconi.
Un rapporto, quello tra la Por Art, il Graffitismo e l’Italia, che ha una lunga storia di accoglimento, sia come contaminazione artistica, che come rassegne espositive museali.
Pittoricamente parlando, sul finire degli anni ’50 e negli anni ’60, la Scuola di Piazza del Popolo a Roma fu la prima a prendere a proprio riferimento, in risposta ad un diverso rappresentare pittorico, tutto il nuovo che da oltre oceano veniva “sparpagliato per il mondo” (per dirla con Giuseppe Ungaretti in “Casa mia”).
Negli Stati Uniti, freschi salvatori del pianeta prima, paladini del consumo di massa subito dopo, Robert Rauschenberg e Jasper Johns avevano riesumato il filone dadaista, quello sublimato e storicizzato da Marcel Duchamp a partire dal 1913.
Si fece trovare pronta “sul pezzo” la Biennale di Venezia, chi l’avrebbe mai detto: Rauschenberg vinse il Leone d’Oro nel 1964, con sommo clamore in Europa. Il terreno per storicizzare la Pop Art era ufficialmente pronto.
Il neo-dadaismo americano non aveva esaurito la potenzialità affascinante (e anche ruffiana) della decontestualizzazione dell’oggetto, del focus sul banale, delle cose di uso e di consumo quotidiani adottate dall’Arte, e adattate ad essa; spuntarono così la cartotecnica che diventava arte stessa, e la manipolazione tecnologica dell’immagine.
Andy Warhol si eresse a profeta di una rappresentazione nuova, quella della creatività riproducibile serialmente, mai attuata prima, se non nell’ Industria: anche l’Arte si appropriò quindi del produrre e del riprodurre, e poi del copiare litografico e serigrafico, che diventarono la tecnica nuova, la risposta tangibile al dilemma posto filosoficamente da Walter Benjamin nel 1936 nel mitico saggio “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” (dilemma sottinteso: quale fine avrebbe mai fatto?).
Una risposta nel nome dell’Artigianato, inteso come “arte-già-nata”.
Che senso avrebbe avuto continuare a creare immagini come olio su tela, o come altra materia su differente supporto, è stato il dilemma ossessivo dell’uomo della Factory, il mitico atelier di New York, luogo di produzione incessante, aziendalmente organizzata (scopo di lucro incluso). Non avevano forse Pollock, De Kooning, Rotko e gli espressionisti astratti suggellato questo dato di fatto in modo definitivo nel dopoguerra, decretando con una forza tombale il decesso del concetto platonico dell’arte come “mimesi”, come rappresentazione imitativa della realtà, della natura e dell’uomo?
Non era del resto dai tempi di Hegel che si prefigurava la “morte dell’arte”? Ecco che questa morte veniva data per sopraggiunta dal 1945 in poi, non casualmente subito dopo Hiroshima e Nagasaki.
Fece esplodere il genio e la produttività di Warhol il domandarsi quale fosse il senso del creare figurazioni di oggetti, di persone e della natura, in un mondo che ne veniva bombardato, le immagini perenni come nuove atomiche non più per la distruzione, ma per la persuasione di massa. Il genere umano si era infatti contraddistinto – con le due guerre della prima metà del secolo – quale distruttore piuttosto che quale costruttore. E poi, in quanto la TV, la fotografia e la cartotecnica dei packaging dei beni di consumo per tutti – come il detersivo Brillo Box o la bottiglia ed il marchio della Coca Cola, o il personaggio di Marylin Monroe (uno su tutti, come potevano esserlo del resto Mick Jagger, la moglie Jerry Hall, Liz Taylor e mille altri) – entravano virtualmente nelle case della gente, generando icone a ciclo continuo.
E’ giusto parlare di “genio” con riferimento a Warhol quindi, sì, ma come derivato dal verbo “generare”: riferito non necessariamente a quanto è straordinario, ma principalmente al suo esatto opposto, a quanto è normalissimamente quotidiano.
Non aveva più senso, per l’originario cecoslovacco nato a Pittsburgh, dare una valenza, una cifra all’opera d’arte, usando il criterio se essa fosse originale o copia, autentica o autografa, “consumata” in galleria, piuttosto che al museo, o magari invece su una rivista patinata, dalla televisione, o sullo scaffale di supermercato.
La discriminante decisiva diventava l’artista, o meglio il produttore, con la sua idea, e con la sua capacità di realizzarla una, dieci, diecimila volte: è così che Andy Warhol, proponendosi apparentemente come mercificatore dell’arte, di essa esalta invece l’essenza, per l’appunto l’idea, contestualmente a colui che viene ad esserne l’inventore.
E’ a tutto questo che avrebbe immediatamente reagito l’Italia – di gran lunga prima e meglio di tutti, reazione, altro che “resilienza” – con l’“integrato” Mario Schifano (per quanto riguarda un periodo circoscritto ma fondamentale della sua copiosa produzione artistica di inizio anni ‘60), e con gli “apocalittici” e meravigliosamente sarcastici Franco Angeli e – soprattutto a mio avviso – Tano Festa.
La proposta di Andy Warhol in Italia a livello di mostre non poteva quindi che essere ricchissima.
Solo ultimamente, contributi molto significativi li abbiamo ammirati a Roma, negli ultimi giorni del 2018 al Complesso del Vittoriano, e a Bologna, la primavera dopo a Palazzo Albergati. Nella prima mostra, la Pop Art di lui fu opportunamente abbinata alla magistrale esposizione dell’espressionismo astratto “dripping” di Jackson Pollock.
Altro da aggiungere non c’è, se non andare a vedere questa nuova mostra “ménage à trois” di Palazzo Belloni a Bologna: è stato lo stesso Warhol a trasmetterci che – come tutta l’arte – anche la sua non deve generare formazione di commenti e costruzione critica di concetti da parte di pochi addetti ai lavori, bensì assorbimento e consumo di immagini a beneficio di tutti, con lavori evocativi e manipolativi di ciò che nella nostra memoria visiva e nel nostro sentire esiste già. Nulla di più per il momento, a risentirci dopo la doverosa visita.
Marco Minossi
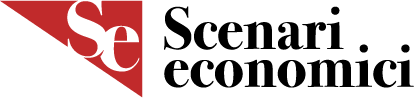
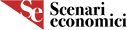





You must be logged in to post a comment Login